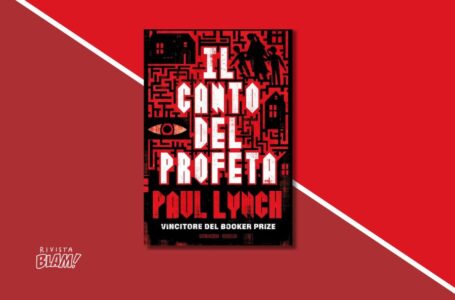La salita: un racconto di Emanuele Muscolino

Illustrazione di Saso Pippia
Arrancava per la salita di ciottoli e di fango, solo e infreddolito, con il muso nell’aria come un animale selvatico. Pini a destra e pini a manca, vento che soffiava da est, si infilava nel bavero della giacca, sotto le maglie larghe del pullover, nel colletto inadatto della camicia. Non ci avrebbe scommesso un soldo che quella natura potesse essere così avversa.
I polmoni non si aprivano, non erano abituati a camminare in salita, e le gambe: due pietre. Lo inchiodavano a terra dicendogli a ogni passo questo è l’ultimo, non ce la fai a scavallare, fermati. Noi ci fermiamo. E quest’aria gialla che mi segue? Per noi fa niente, gli dicevano i polmoni, basta che ti fermi e che te ne torni in discesa e poi in piano, con comodo, come sai fare tu. Non devi farci nulla di eroico con questo arnese, gli diceva il cuore. Già, il cuore. Solo ora lo sentiva. Il suo cuore nudo straziato. Non c’era che quel motore a spingerlo, uno straccio di carne senza acciaio né lamiere. La città era la sua casa, dolce, pianeggiante: le strade, i corridoi, l’ufficio, l’ascensore, i tapis roulant. Per salire c’era l’automobile, un motore a benzina, ottanta cavalli che non protestavano se gli aprivi il gas.
La cima era lontana, ma quel nanerottolo allegro spingeva la bicicletta a rotelle come ci dovesse arrivare davvero. Com’è possibile che il cuoricino non si sia ancora stancato? Ai bambini piace la discesa, no? Non si è deciso a girare l’arnese e a buttarsi giù? Avremo già fatto un chilometro. Davvero vuole arrivare in cima? Ma se glielo hai detto tu! Certo, glielo ho detto io ma ero sicuro che si sarebbe stancato prima. I bambini non si stancano mai, lo sai. Non me lo ricordo com’ero da bambino. Ma come t’è saltato in mente di diventare papà a cinquant’anni? Non c’entra, non c’entra, sono secoli che lavoro a una scrivania otto ore al giorno. Pure a trent’anni non ce l’avrei fatta a stargli appresso. I bambini sono bambini: sono fatti per correre. «Fermati, Leonardo!» Ma non mi sente, è fuori dall’eccitazione. «Fermati, ho detto!» Ma chi sei tu per dirgli niente? Sei la strada, sei l’erba, sei gli alberi? Sono il papà. Sei l’aria gialla della città, che lo vuole prendere al cappio. E invece lui ha vita da vendere e non te ne darà neanche un po’. Hai fatto il tuo tempo, fermati, Umberto.
Invece Umberto continuava a salire, una gamba appresso all’altra, con la giacca a vento del suocero che gli aderiva attorno alla pancia oblunga. Le vacanze di Natale si passano in famiglia, al caldo, in pantofole, a mangiare e a bere. Ma Leonardo vuole uscire, andare in campagna, dai nonni: «Portiamo la bicicletta, così fai dei gran bei giri in giardino». «Macché giardino! Io voglio andare su, in cima alla collina.» «Bene, ti ci porto, vediamo se ci arrivi.» «Ci arrivo» aveva detto Leonardo. Ed era partito come un ragnetto, culo in sella e zampe come propulsori. Si era messo a pedalare e non aveva più smesso, con il giubbetto che la mamma gli aveva chiuso fino al collo e il sudore caldo che gli si freddava sulla schiena, scendendo come rugiada. Non la vedeva quella pezza che si trascinava alle sue spalle e non sentiva la sua aria puzzolente: vedeva soltanto il sole accarezzare le querce su in cima, nel fresco del pomeriggio.
Umberto ci navigava con un fastidio tremendo nell’umore delle sue calze e a stento sopportava la lastra gelida sulla schiena e l’alluce che aveva preso a bruciargli e anche il pranzo, che gli si ribaltava dentro. Il suo corpo era da buttare. Glielo stavano dicendo tutti. Rallentò il passo e prese a protestare: E che − disse il cervello − forse sta scritto da qualche parte che io debba salire? Non è mica territorio mio, questo, sono uomo d’ufficio io. Porto a casa il pane, faccio crescere un figlio, provvedo alla famiglia. Ho diritto a un po’ di riposo. Dovevo stare in poltrona a ronfare e a bere il mio limoncello, sant’Iddio!
Si fermò e si chinò per riprendere fiato. Quando alzò gli occhi, Leonardo non si vedeva più. Si sporse, cominciò a chiamarlo. Lo chiamò dieci, venti volte − «Leonardo, non sto scherzando, rispondi» – fino a che non ebbe più aria nei polmoni. Ordinò al piede destro di fare un passo: la gamba si alzò come un piumone bagnato. Ordinò al sinistro di fare lo stesso e pure l’altra si mosse. Ripeté l’azione quattro o cinque volte, raschiando il fondo di un cuore morente, poi cadde piegato in due, con le vene delle tempie che tamburellavano all’impazzata e lo stomaco che si contorceva. Per qualche istante non vide nulla e andò a tentoni per trovare il cellulare nella tasca. Niente linea. Pensò di scendere a valle per chiamare i soccorsi, ma ci sarebbe voluto troppo tempo e Leonardo, lassù, sarebbe andato nel panico. Alzò gli occhi e contò fino a cinque: il figlio sarebbe comparso all’orizzonte, ne era certo. Bastava attendere. Contò fino a dieci; passò un minuto intero. Nel bosco, Umberto era più solo di un bambino.
Non gli rimaneva che rimettere in moto il suo rottame scoreggiante e provare a raggiungerlo. Staccò da terra le due zavorre e le lanciò verso la cima: il motore gli rimbalzò nella gola e gli disse di smettere. Umberto proseguì più lento, inciampò, sbatté le ginocchia e si macchiò i pantaloni a coste. Si rialzò con i palmi delle mani rigati e riprese il cammino. Ogni tanto chiamava il figlio, senza più pensarci, mentre le scarpe scalciavano sassi e le braccia aravano i rovi che chiudevano il sentiero. Si ricordò di come gli avevano insegnato a respirare nell’ora di educazione fisica e spalancò la bocca, tirando dentro grandi sorsate d’aria. Sentì il vento avvolgergli il collo, gelargli il petto e la schiena, dirgli anche lui tornatene a valle. Ma la cima era vicina. E chi se ne frega che è vicina, gli dissero. Lo fecero inciampare, lo buttarono a terra. Umberto si rialzò, si trascinò avanti. Quella collina lo stava avvicinando alla morte e ormai avrebbe potuto solo morire, non certo fermarsi. Cadde di nuovo e uno sputo di sangue affiorò dal buco dei calzoni. La cima era lì, la poteva toccare. L’aria gialla si era persa a valle e Umberto, chino come un cane, respirava. Respirava come doveva respirare Leonardo sulla sua biciclettina, da qualche parte in alto. L’alluce, le zavorre e quella pancia oblunga si rimisero in cammino. Umberto! Quanto tempo hai perso. Umberto, hai cinquantatré anni e sei morto, disse il cuore. Non sono ancora morto, batti pure, continua a battere. Il ginocchio destro scricchiolò due o tre volte e le lacrime gli bruciarono gli occhi, ma Umberto li tenne aperti. Quella vecchia spingarda ce la stava facendo: borbottando, singhiozzando, perdendo pezzi.
Il sentiero si aprì in una rada e una macchia rossa e blu − i pugni sul manubrio e il cappottino abbottonato − comparve nel mezzo. «Papà» urlò Leonardo. «Papà, quanto ci hai messo! Ti stavo aspettando per fare la discesa! Sei pronto?»
Il torace di Umberto si espande e gli libera il cuore, la bocca increspata di sangue e di terra si allarga in un sorriso che non trattiene, l’orizzonte precipita in una vertigine. Ci sono le montagne oltre la collina, e sulle montagne la neve risplende. Umberto riprende fiato: «L’hai vista la neve, Leonardo?». «Sì, papà, l’ho vista mezz’ora fa, la neve. Ora devo fare la discesa supersonica.» «Va’ piano per la discesa, i freni sempre tirati, che cadi.» «Sì, papà, certo, non ti preoccupare.» Leonardo si lancia giù, verso la casa dei nonni. Umberto gli urla aspetta.
Ma non c’è nulla da aspettare. Non è più il tempo di aspettare.
Emanuele Muscolino