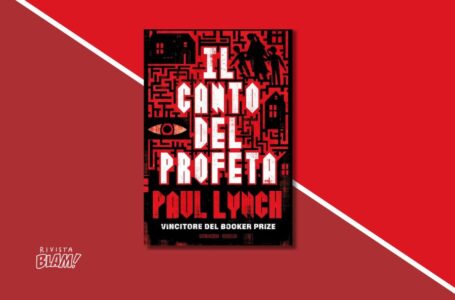Il racconto della domenica: Tredici maggio di Mattia Cecchini

Illustrazione di Amanda Lertora
Entrò nella stanza fredda stringendosi la cravatta: sotto il camice dovevano regnare ordine e decoro, come nella sua clinica. Al centro, curva su una brandina, la vecchia infermiera legava le cinghie attorno alle caviglie del matto.
«Le stringa più forte.» ordinò, mentre infilava i guanti in lattice.
Dal tavolo accanto alla brandina il dottore afferrò una sorta di tenaglia, la fissò alle tempie del matto e si sedette là vicino.
L’infermiera, con le mani piegate sulla pancia, si allontanò. L’ultima volta, prima della terapia, aveva fatto il segno della croce, e il dottore le aveva gridato asina. Lei e il suo dio siete due asini, aveva detto. Poi si era lisciato i baffetti neri.
Dalla tasca del camice il dottore tirò fuori un taccuino, cuoio pregiato dal Portogallo, e appuntò la data. 20 dicembre 1941.
«Per Natale avrà una mente nuova, finalmente sana» disse rivolto al matto, colpendolo sulle guance spellate. Guardò l’infermiera, ingobbita in un angolo:
«Il suo dio crea danni come questo» indicò il matto, «e io li riparo.»
Si voltò verso due manopole nere, le ruotò con calma, e il matto tremò, attraversato dalla corrente. Sopra le manopole una lancetta rossa s’impennava e indicava numeri sempre più grandi. Il dottore alzò ancora la tensione e il matto tirò i tendini del collo, parevano pronti a strapparsi. L’infermiera coprì gli occhi con le mani.
«Ma cosa fa? Non guarda il miracolo?» strillò il dottore.
Poi le manopole non poterono più ruotare, la lancetta si bloccò su un numero troppo alto, e il matto bagnò di piscio i pantaloni già sudici.
Il dottore scattò in piedi e la sedia si rovesciò dietro di lui. Mentre scappava dalla stanza disse: «La prossima volta si ricordi il catetere» si sfilò i guanti e li buttò ai piedi dell’infermiera. «Pulisca tutto in fretta, alle dieci abbiamo un’altra terapia.»
Dalla bocca spalancata, la bava del matto si tuffava per terra.
Fuori dall’ufficio del dottore, nell’anticamera infestata da quadri, la signora Giovanna Retaggi aspettava composta. Lo sentì arrivare, passi svelti come un soldato, poi lo vide sbucare da dietro un angolo. Si alzò accarezzandosi le pieghe della gonna.
«Allora, dottore, come sta?»
«Molto meglio, ogni giorno un progresso.»
«Quando potrò rivederlo?»
«Presto» il dottore aprì la porta dell’ufficio e indicò una poltrona alla signora.
«Già a Natale?»
Il dottore ripensò ai pantaloni del matto, zuppi alla fine della terapia.
«Forse ad anno nuovo, non bisogna affrettare la cura.»
«Grazie al cielo» la signora si sedette sul bordo della poltrona. «Sa, per queste feste abbiamo ospiti.»
Il dottore, dietro la scrivania, aprì il cassetto e tirò fuori la pipa. La riempì di striscioline di tabacco poi l’accese con il fiammifero.
«Il segretario del partito sarà a pranzo da noi a Natale.»
Rami di fumo grigio nascondevano il volto del dottore.
«Mio marito deve convertire l’azienda, non possiamo permetterci figuracce.» La signora appoggiò le piccole braccia sulla scrivania, pareva volesse affacciarsi per vedere meglio il dottore. «Lei ci capisce, vero? Noi vogliamo bene a nostro figlio, ma con quelle idee…» la signora si confuse.
Coperte dal fumo, le sottili labbra del dottore spiegarono: «Quelle non sono idee, sono deliri: le idee, anche quelle sbagliate, sono il frutto di una mente sana, mentre i deliri, che non sono mai giusti, sono il frutto marcio di una mente malata».
Dalla borsetta nera la signora sfilò un fazzoletto di raso. Si tamponò con cura i granelli di lacrime comparsi sotto gli occhi.
Renatino Retaggi, primo e unico figlio dell’imprenditore Corso Retaggi e della marchesina Giovanna Trotti Bentivoglio, aveva dieci anni la prima volta che lo legarono con la camicia di forza.
Quella volta era diventato amico di un contadino stecchito dal sole, uno di quelli che zappava i campi della marchesina appena fuori dal paese. Il contadino, che si faceva chiamare Ganascia, usciva dalla sua baracca quando il gallo si sgolava a cantare, e tornava la sera prendendo a calci la terra.
All’inizio Renatino stava lontano da Ganascia, lo spiava da dietro un albero o accucciato sotto un muretto. I suoi genitori l’avevano avvertito: stai lontano dai cafoni, sono morti di fame, ti mangerebbero pure le dita. Lui aveva nascosto le mani nelle tasche, poi aveva chiesto chi fossero i cafoni. Sono quelli che lavorano nei campi, aveva detto la marchesina. Lavorano? Battono la fiacca! Aveva aggiunto l’imprenditore.
Una mattina, mentre il sole bruciava anche le pietre, Renatino si avvicinò piano a Ganascia. Tra le manine nascondeva una crosta di formaggio, l’aveva rubata la sera prima a cena. La mostrò al contadino e gli disse che non c’era bisogno di mangiargli le dita. Potevano essere amici.
Ganascia prese la crosta di formaggio.
«Gli amici bevono il vino insieme, questa va bene solo per i topi.» infilò la crosta nella tasca. «Il mio bimbo però sarà contento.» e ricominciò a zappare.
«Il tuo bimbo è un topo?»
«Mah, mica è tanto più grande di un topo.»
Pochi giorni dopo Ganascia invitò Renatino nella sua baracca. Lui saltava, impaziente di vedere il bambino topo, e il contadino calciava la terra. La baracca era in fondo a una stradina misera, pareva un sentiero, e sulla terra là intorno crescevano solo erbacce gialle.
Entrarono nella baracca: un solo stanzone con una finestrella. Il figlio di Ganascia, abbandonato sul tavolo, strillava. Dal corpicino nudo spuntavano due braccia e due gambe simili a rametti secchi. Gli manca la coda, pensò Renatino, ma davvero non è tanto più grande di un topo. Là vicino, coperta dal fumo di un pentolone, una donnina salutò Ganascia.
Nell’angolo più buio della baracca era stesa una manciata di paglia.
«Là ci dorme una pecora?» domandò Renatino, indicandola.
Ganascia gli spiegò che quello era il suo letto, che là ci dormiva con sua moglie e con il bambino, che quella vitaccia stenta che facevano era colpa della marchesina e dell’imprenditore: «Io zappo i campi tutto il giorno, e loro si prendono il raccolto, l’affitto e tra poco anche il sangue».
Renatino piegò la testa. «Scusa.»
«Ma tu mica c’entri nulla, la colpa è tutta loro.» Ganascia fece un cenno verso il paese, dov’era la villa di Renatino. «Solo chiedi a tua madre cos’è che ci vuole fare con il mio sangue, perché c’è rimasto giusto quello da rubarmi.»
Quella sera Renatino, rientrato di corsa a casa, si asciugò le lacrime sulla gonna della madre. Lei era in piedi accanto al tavolo. Controllava se la nuova domestica avesse messo le posate dritte, se ci fossero i piatti giusti e abbastanza bicchieri.
«Perché vuoi rubare il sangue di Ganascia?» le chiese strusciando il naso sulla stoffa. «Perché lui dorme sulla paglia e noi abbiamo due letti?»
La marchesina scostò il figlio e s’inginocchiò. «Non ci devi parlare con i cafoni.» si affrettò a cercare un fazzoletto per pulirsi la gonna.
Renatino alzò un piatto e lo tirò contro la madre. Le urlò che era una strega. Che trasformava i bambini in topi. Che era vergogna pigliare il raccolto senza zappare. Poco dopo tornò a casa anche suo padre. Con il cappello ancora indosso, che gli strozzava la grossa testa, calpestò i cocci del piatto. Sollevò Renatino per le orecchie. Prima gli disse di calmarsi e poi, quando Renatino cercò di prenderlo a pugni, si sfilò la cinta.
Renatino non si calmò neanche dopo le frustate del padre; e passati tre giorni, con la schiena zuppa di sangue, urlava ancora strega a sua madre. Al quarto giorno, di mattina presto, lo trascinarono all’ospedale e prima di pranzo era finalmente muto e spento. Le braccia legate intorno al corpo.
Si svegliò solo il giorno dopo, con i nervi stropicciati e gli occhi gonfi. Accanto a lui c’era la madre, che gli accarezzava i capelli rossi. «Promettimi che non farai più il matto» lo supplicò.
In fondo al letto, dritto come un muro, il padre scuoteva la testa. «Spera per te che non accada più» l’avvertì. Sotto il panciotto brillava la cintura.
«Non farò più il matto» disse, «lo giuro.» E qualche anno dopo aveva già rotto la promessa.
Si piantava al centro della piazza del paese, quando c’era il mercato, ma anche quando gli impiegati uscivano dagli uffici e le botteghe chiudevano, montava su uno sgabellino e con le vene del collo gonfie gridava: «È un demonio! Date retta a me, è il figlio del diavolo» e mostrava, alla gente che rideva, la foto del duce. «Ha un alito maligno, state lontani da lui e da chi lo venera, basta un solo soffio per farvi dannare.»
Quelli delle squadriglie, avvolti nelle camicie nere, non si davano neppure la pena di picchiarlo. Rimanevano ai bordi della piazza e si davano di gomito. Uno matto così non poteva essere neanche un avversario politico.
«Sotto l’uniforme nera tiene nascoste le sue sette teste da dragone. Sono questi i tempi dell’Apocalisse.» continuava a strillare Renatino.
Una mattina di dicembre, con gli occhi ancora piegati di sonno, qualcuno si accorse che Renatino non era più al centro della piazza. L’imprenditore Corso Retaggi l’aveva preso per i capelli e trascinato fino all’ospedale. «Lo rinchiuda per sempre.» ordinò al dottore.
«Non ce n’è più bisogno.» rispose lui.
Poco dopo, il dottor Corrado Valli spalancò una stanza fredda. Indicò con la pipa un macchinario simile a una radio e spiegò, all’incredulo imprenditore Retaggi, i benefici della terapia elettroconvulsivante.
Ad anno nuovo, con i nervi ancora sgualciti, Renatino barcollava fuori dalla clinica, appoggiato addosso alla madre.
«Non lo farai più il matto, vero?» chiese lei. «A tuo padre gli farai prendere un infarto.»
«Guardami» provò a spalancare le braccia. «ormai sono guarito.»
E due anni dopo lasciò sulla scrivania del padre un biglietto. Piegato sotto una stilografica.
“Me ne vado a combattere con gli angeli”, aveva scritto.
«Meglio così» l’imprenditore Retaggi cercava di consolare la marchesina, quasi svenuta sul divano. «Lasciagli fare il matto in cielo, quaggiù non serviva a niente.»
Ma già la sera la marchesina correva verso suo marito, che rientrava a casa e si sfilava il cappotto. «È vivo!» gridò di gioia e gli prese il cappello.
L’imprenditore si spaventò. «Come è vivo?» portò la mano sul taschino della giacca, poco sotto c’era il cuore che si rompeva.
«In paese dicono che è scappato con i partigiani» la marchesina abbracciò il marito.
Lui si slacciò dalla moglie e cadde a terra. «Se non lo ammazzano i tedeschi, l’ammazzo io.» giurò l’imprenditore Retaggi.
A maggio del settantotto il dottor Corrado Valli era ormai in pensione.
Una volta al mese, nella villetta circondata dai cespugli, riceveva la visita del primario che l’aveva sostituito. Era uno dei suoi vecchi studenti, uno che gli aveva leccato i piedi all’università, che dopo la laurea aveva continuato a leccargli i piedi anche alla clinica, e che quello che non aveva saputo ottenere con le leccate, gli era stato garantito dal padre onorevole. Come il lavoro da primario.
Seduti alla scrivania bevevano una tazzina di caffè, parlavano in fretta del tempo, e alla fine il primario tirava fuori dalla valigetta le cartelle dei matti. Le incolonnava una sopra l’altra e le metteva da una parte, poi ne apriva una per volta e si mettevano d’accordo su cosa fare. Mentre chiudeva la cartella di Rosa Miccoli, una depressa a cui aumentare le pillole, il primario chiese al dottor Valli: «Cosa ne pensa di questa nuova legge?».
«Basaglia è un cretino.» serrò la mascella, come se Basaglia fosse nella sua bocca e lo potesse masticare. «Una volta che avrà chiuso i manicomi, dove pensa di metterli tutti questi matti?»
Il primario prese un’altra cartella.
«Il mondo ha sempre funzionato male anche con i manicomi aperti» continuò il dottor Valli. «S’immagini con i manicomi chiusi.»
Sotto il mento del primario era aperta la cartella di Renatino Retaggi. «Quel Basaglia è un demonio! Dia retta a me, è figlio del diavolo» scandì tutte le parole battendo il pugno sulla scrivania.
La fronte del primario si aggrottò di rughe. Guardò cupo il vecchio dottore.
«E Retaggi come sta?»
Renatino, appena finita la guerra, era tornato a casa. Il padre l’aveva abbracciato stretto, gli aveva detto che gli voleva un gran bene e la mattina dopo l’aveva riportato in manicomio. «Tenetevelo» ordinò a due con l’uniforme bianca. Salutò il figlio con una spinta.
Renatino rimase chiuso in manicomio, a festeggiare gli infermieri e i medici che andavano in pensione uno dopo l’altro. Puliva le latrine, imboccava quelli legati, e la sera si addormentava per primo. Chi non lo conosceva gli chiedeva cosa ci stesse a fare là, sembri meno matto della gente fuori, dicevano. Lui rispondeva che lì dentro era anche felice. Allora chi aveva fatto la domanda capiva: Renatino era quello più matto.
«Questo mese è peggiorato ancora» cominciò il primario. «L’altro ieri abbiamo dovuto legarlo.»
«Glieli avevate tolti i giornali?»
«Sì, appena ce l’ha ordinato lei.» spiegò il primario, allentandosi la cravatta. «Forse è stato fatto troppo tardi. Ormai anche lui sa della legge Basaglia.»
«E cosa dice?»
Il primario guardava in basso, era tutto chino sui fogli della cartella. «Retaggi la pensa come lei, dottore» balbettò.
Il dottore fece un cenno al primario, doveva parlare senza bloccarsi.
«Anche lui crede che Basaglia sia un demonio» il primario lesse con timore gli appunti sul caso Retaggi. «Dice che è il figlio del diavolo.»
Il dottore sospirò.
«Non c’è altro da fare, allora» il dottore si grattava la fronte. «Da lunedì somministri al Retaggi la terapia elettroconvulsivante.»
Rifletté e poi aggiunse: «Dodici sedute possono bastare».
Il primario chiuse la cartella Retaggi senza chiedere spiegazioni, ma il dottor Valli precisò: «A volte le idee possono essere sbagliate, ma rimangono il frutto di una mente sana. Quelle di Retaggi non sono idee: sono semplici deliri, e quelli sono sempre il frutto marcio di una mente malata».
Mattia Cecchini