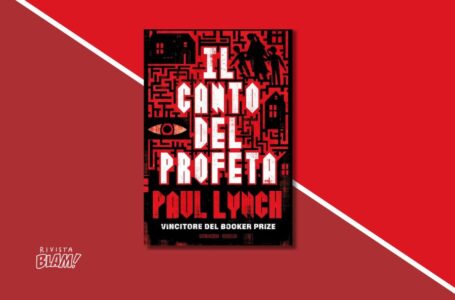Bar Achille di Jacopo Ferri: racconto vincitore del premio letterario L’Avvelenata 2021

Illustrazione di Francesca Paola Turco
Dopo la scuola passarono due anni, o forse tre. Quando vivi in provincia fa lo stesso. Trascorrevo le giornate al bar del vecchio Achille, dove i soliti quattro gatti spendevano pomeriggi interi a bere birra e a fumare, sputando sopra i giornali con i risultati della domenica sportiva.
Pulivo i tavoli, lavavo i piatti. Durante le feste, al paese saliva qualcuno dalla città e allora Achille mi metteva a spillare un po’ di birra: «Basta che non fai troppa schiuma, Albe’!» diceva. «Quella giusta!» e così servivo da bere ai giovani venuti da fuori, allenando lo sguardo al giusto quantitativo di bollicine che, secondo Achille, doveva contenere una qualsiasi pinta, degna di questo nome.
I ragazzi della città li riconoscevi dalle scarpe. Avevano tutti quei nuovi modelli da ginnastica, bianchi, immacolati, niente a che vedere con i miei scarponcini sporchi di terra che puzzavano di merda una volta sì e l’altra pure. Pesavano un quintale, ma ci spaccavi le pietre come fossero fatte di burro. Con la punta in ferro era come colpire un vaso di cristallo. Una volta, ci rimediai il numero di una:
«Non ci credo che se tiri un calcio a quella pietra si spacca».
«Scommetti?»
«Scommetto!» e così m’ero guadagnato il numero di una bella ragazza di città. Purtroppo, come spesso accadeva dalle mie parti, se ne partì la sera stessa senza tornare più. Avrei potuto farle vedere il punto dove il lago si univa con il fiume; Mauro aveva convinto una a fare sesso con lui da quelle parti, una volta, o almeno così mi aveva raccontato.
Mauro aveva la mia stessa età, ma la scuola l’aveva già finita da un pezzo, dopo le medie il padre l’aveva messo ad arare i campi perché non c’erano abbastanza soldi per pagare chi lo facesse al posto suo.
«Almeno guidi il trattore, no? Io che palle dietro quei banchi a non fare un cazzo!»
Lui aveva risposto alzando le spalle. Rispondeva sempre così quando dentro sentiva un vuoto che gli bruciava, ma non capiva cosa fosse. Quando era sabato sera e la saracinesca del bar di Achille si abbassava, io e Mauro saltavamo sul vecchio furgoncino ammaccato del padre e ce ne andavamo di nascosto in un capannone abbandonato ai bordi della statale, a sentire musica da un vecchio stereo e a farci gli spinelli al sicuro dalla polizia. Una sera, ci beccammo un gruppo di mezzi hippie che avevano piazzato le tende là fuori, per una notte o due.
«Davvero fumate ’sta merda?» ci avevano chiesto, offrendoci dell’erba buona. Mauro stava per incazzarsi, ma poi ridemmo insieme tutta la notte.
I giorni passavano come il vento tra gli aghi di pino: lenti, quasi impercettibili. Eppure, il tempo continuava a scorrere. Te ne accorgevi quando, di tanto in tanto, si portava appresso qualche vecchio che aveva fatto la storia del paese «La prossima so’ io!» diceva sempre la signora Maria che campava da più di cent’anni, e Achille con la mano sinistra faceva le corna e con la destra si grattava, perché quando la vecchia diceva così qualcuno più giovane ci lasciava le penne.
Oltre questi sporadici avvenimenti che scandivano il calendario, per noi che passavamo le giornate al bar – chi per lavorare e bere, chi solo per bere – ci sembrava che ogni giorno fosse lo stesso. Aveva il suono di una musica che non stanca mai e sebbene delle volte sentivo uno strano vuoto, simile a quello che faceva alzare le spalle a Mauro quando si parlava della vita, credevo che non avrei cambiato quelle abitudini per nulla al mondo.
Ma poi, incontrai lei.
Achille quella sera se ne era andato un paio d’ore prima lasciando le chiavi sul bancone del bar: «Chiudi tu, oggi. Io ho un appuntamento col destino». Diceva così quando il sabato sera andava a giocare a poker con gli amici di una vita. Probabilmente, però, il destino gli aveva sempre dato buca, perché il lunedì veniva a lavoro più incazzato che mai, e allora erano guai.
La prima volta che la vidi se ne stava insieme a un gruppetto di ragazzi di città. Lei portava un cappotto nero che le arrivava ai piedi, mentre gli amici indossavano tutti quelle giacche gonfie con la pelliccia intorno al cappuccio, manco fossero appena arrivati sui monti innevati del Nepal. Io e Mauro li prendevamo sempre per il culo quando li vedevamo conciati così, poi con quelle scarpe da ginnastica: non c’entravano proprio niente.
«Mi fai un rum e cola?»
«Che?»
«Un rum e cola» ripeté lei; i suoi occhi erano castano chiaro, ma a me ricordavano il colore dell’acqua del fiume quando la corrente si fa più forte e la terra si alza dal fondale.
«Qui il rum lo serviamo liscio» gli risposi io.
«Cazzo! Nemmeno il rum e cola fanno, Miche’!» s’intromise uno dei ragazzi, rivolgendosi a un altro.
«Allora andiamo, ché al paese dopo ci sta pure il biliardo.»
«Aspettate» lo interruppi io. «Il primo giro è gratis, ma vi faccio una genziana.»
I quattro si guardarono l’un l’altro, poi il più alto disse:
«Se la metti così…» e si misero seduti sugli sgabelli davanti al bancone.
Quello che aveva appena parlato sembrava più grande degli altri di almeno un paio d’anni, aveva i capelli sparati all’insù e il buco all’orecchio. «Una cosa da finocchio» avrebbe commentato il vecchio Achille.
«Ehi, Carola, ne vuoi uno?» domandò uno con la testa rasata ed il naso pronunciato alla ragazza dei miei sogni.
Il suo nome era Carola, quindi.
«Vabbè, però il mio me lo pago» e fece per prendere il portafoglio nella borsa. Riempii i bicchierini fino all’orlo e glieli porsi su un vassoio.
«Tranquilla, questo giro lo offre la casa» posò la borsa sullo sgabello accennando un sorriso: i suoi denti mi ricordavano le nuvole d’autunno sul lago.
«Ma è vero che qui passate l’inverno a masturbavve?»
«E sta’ zitto, Anto’! Ma che cazzo di domande fai?» quello più alto tirò una pacca sulla spalla dell’amico rasato, Carola era diventata rossa dalla vergogna.
«Fate proprio schifo!» aggiunse lei. Poi, andò a sedersi a un tavolo all’angolo della sala dimenticando il bicchiere sul bancone.
Accennai un sorriso; ci fosse stato Mauro gliele avrebbe suonate per molto meno, ma non ero un attaccabrighe, io. Presi il bicchiere pieno e feci il giro della cassa posandolo sul tavolo dov’era seduta.
«Scusalo, è solo un coglione» disse.
Ridemmo insieme.
«E così, vivi qui?»
«Ci sono nato, sì.»
«Fico!» esclamò, ma con quel tono di quando lo si dice tanto per dire. Prese il bicchiere e fece un piccolo sorso, le guance gli divennero rosso fuoco.
«Cavolo, come brucia! Ma come fate a bere ’sta roba?»
«Dopo un po’ d’inverni a lavorare con Achille ci fai l’abitudine.»
«Achille?»
«Il proprietario del locale.»
«Ah, quello con la gamba di legno?»
«Proprio lui.»
Il vero nome di Achille era Umberto, ma tutti lo conoscevano con il soprannome di Achille. Durante la Seconda guerra mondiale, all’età di dieci anni, aveva messo il tallone su una mina antiuomo ed era rimasto lì fermo per tre giorni, in attesa che qualcuno venisse a salvarlo. L’aveva trovato il cugino: stremato e quasi morto di sete, ma con il tallone ancora ben piazzato sull’ordigno inesploso. Quando vennero i soldati, ci misero diverse ore per disinnescare la mina, ma alla fine riuscirono a portarlo a casa sano e salvo. Tallone e piede compresi.
Però il destino, si sa, agisce in modo curioso.
Alcuni mesi dopo, la sua casa crollò sotto un bombardamento aereo e lo stesso piede gli rimase incastrato tra le macerie per un giorno intero, quando lo tirarono fuori la gamba era in cancrena e dovettero amputarla fino alla rotula. Il soprannome Achille era venuto poi, grazie all’insegna luminosa del locale: bar achille.
«Vieni spesso da queste parti?»
Carola sorseggiava la genziana come fosse una tazza di tè. «Sono salita un’altra volta. Volevo far conoscere il posto ai miei compagni, ma forse non fa per loro.»
«Ci sei mai stata al fiume?» solo a dirlo sentii lo stomaco stringersi in una morsa d’emozioni.
«L’altra volta ero arrivata a metà sentiero, ma poi mi sono fermata per paura di perdermi.»
Nel frattempo, i tre ragazzi avevano preso a giocare al calciobalilla, due contro uno, e ogni volta che qualcuno prendeva gol si vendicava con gli altri bestemmiando.
«Se vuoi un giorno ti ci porto io.»
«Carola, ci serve il quarto!» urlò uno dei ragazzi. La sua voce coprì la mia proposta avventata.
«Che palle» fece per alzarsi, ma la trattenni con la mano.
«Gioco io se volete.»
Accettarono.
A ogni palla che toccavo, una bestemmia.
Facemmo altre tre partite, poi tornai a servire al bancone. Finito il turno ci scambiammo due battute e fumammo una sigaretta insieme.
«Allora la prossima volta mi porti al fiume» disse Carola.
Lo stomaco mi si attorcigliò più di prima. Quando risalirono sulla loro utilitaria era quasi mezzanotte.
«Andiamo a un locale in città, vuoi venire?»
Misi da parte lo strano vuoto che sentivo, e invece di un’alzata di spalle o un sorriso smorzato, come avrebbe fatto Mauro, feci rispondere la forza dell’abitudine:
«Devo chiudere il bar, e sono stanco morto, ma grazie lo stesso». Sparirono oltre la curva portando via con sé Carola, le bestemmie, e le loro scarpe da ginnastica bianche. Mezz’ora dopo Mauro mi passò a prendere e ce ne andammo al capannone abbandonato sulla statale, che quella notte mi sembrò più misero e desolato che mai. Fumammo una canna, scherzammo un po’, ci mettemmo a guardare le stelle.
«A Ma’, hai presente quel vuoto che senti dentro ogni tanto, ma non sai mai da dove viene? Forse l’ho capito, sai.»
Mauro fece un tiro. Alzò le spalle. Ciccò per terra.
«Quale vuoto, Albè?»
«Lascia perdere.»
Nei mesi successivi lavorai al bar dalla mattina alla sera facendo spesso doppio turno. Achille se ne stava seduto tutto il tempo con la gamba di legno distesa su una sedia guardandomi lavorare. Ogni tanto dispensava un consiglio che assumeva sempre le fattezze di un ordine. Io obbedivo taciturno, lui se la rideva. Quando mi vedeva stanco era solito dire: «Quel bancone ti spezza le gambe e tu ce ne hai ancora due». Non capivo se lo dicesse per motivarmi, o per vendicarsi con il destino in qualche modo. Fatto sta che ogni sera se ne tornava sempre a casa barcollando, ubriaco fradicio. Dopo il terzo bicchiere faceva discorsi profondi sul tempo che passa e su come la vita fosse un campo minato in cui devi stare attento a dove metti i piedi, ma che in qualche modo devi riuscire ad attraversare senza saltare in aria. Una partita che non puoi esimerti di giocare.
«Troppa gente abbandona prima ancora di iniziare, almeno io c’ho provato ad attraversarlo, quel campo. Ho corso i miei rischi e m’è andata pure bene, però se poi il cielo ti casca addosso, c’è poco da fare. È come a poker: quando hai una mano di merda, ma ti decidi comunque ad andare fino in fondo, delle volte la sorte ti sorride» poi scatarrava, sputava in un fazzoletto e si faceva un altro bicchiere. Per capirlo dovevi ascoltarlo bene.
Quando la settimana giungeva al termine, vagonate di ragazzi di città varcavano la porta del bar con le loro solite scarpe da ginnastica bianche e immacolate.
Di Carola, però, nemmeno l’ombra.
Una volta, tra il viavai dei turisti, vidi il ragazzo basso rasato, quello con il naso pronunciato che pensava solo alle seghe, stava con un altro gruppo e se l’atteggiava come uno del posto.
Facemmo qualche partita a biliardino. Bestemmie.
Poi, prima che se ne andarono gli chiesi: «Carola sai quando sale?».
«Non la sento da ’na vita, c’ho litigato co’ quelli» e se ne partì con il suo gruppetto di amici moribondi d’alcool.
Quando non ero di turno, io e Mauro avevamo preso a uscire con un altro ragazzo del posto un po’ più grande di noi. Si chiamava Massimo, ma tutti lo soprannominavano Maxxi, pronunciato come Maxi, però scritto con due x, perché gli unici vestiti che gli entravano erano quelli xxl, talmente era ciccione.
Una volta scegliemmo di portarlo perfino al capannone abbandonato, anche se lui le canne non se le faceva. In compenso però beveva come un bastardo, più di me e Mauro messi assieme. Parlavamo un po’ di tutto: del calcio, delle ragazze, anche se in giro se ne vedevano sempre meno e di Carola non feci mai il nome. E se per caso si arrivava a fare qualche discorso più impegnativo, finiva sempre con Mauro che alzava le spalle e Maxxi che si metteva a bere, o a mangiare. Forse teneva a bada così il suo vuoto, Maxxi. Tracannando lattine di birra e aggiungendo nuove “x” al suo nome. Peccato che il cuore gli si fermò a ventisette anni suonati. Infarto, dissero i medici. Così giovane era un fatto raro.
«La prossima so’ io», disse la signora Maria.
Passarono un paio di anni.
Ogni venerdì avevo preso l’abitudine di andare al paese vicino a comprare il gratta e vinci. Ne prendevo sempre due, uno per me e uno per Mauro. Il sabato sera li grattavamo insieme ai capannoni, anche se ultimamente ci scendevamo sempre più di rado.
«Perché non compriamo i gratta e vinci al bar di Achille?»
«Perché ci lavoro lì, non vale. E poi, Achille porta sfiga.»
Di solito fantasticavamo su cosa ci avremmo fatto con tutti quei soldi. Mauro avrebbe comprato nuovi terreni da regalare al padre, solo per il gusto di assoldare un esercito di lavoratori che portassero il trattore al posto suo, trascorrendo le giornate al bar di Achille a offrire a tutti alcool dalla mattina alla sera. Io con la fantasia mi spingevo oltre e sognavo di andare a vivere in città. Non gli dissi mai che il mio sogno era quello di ritrovare una ragazza incontrata anni prima, per una sera, con cui avevo scambiato soltanto poche battute al tavolo del bar. Chissà se mi avrebbe riconosciuto dopo tutto quel tempo, chissà se l’avrei riconosciuta io. Ma ero convinto di sì. Quegli occhi castani li rivedevo spesso, come due ampolle di terra giacevano brillanti sul letto sfocato del fiume.
«Albé, che c’hai?»
«Niente, niente» l’immagine di Carola scomparve assorbita dal fumo della canna.
Brindammo alla sorte e ci scolammo le lattine di birra tutte d’un fiato.
Mauro non ci credeva a quella storia dell’andarsene a vivere in città, appoggiava le mie fantasie, come io le sue, ma non le prendeva mai sul serio. Eppure, quando ci pensavo, sentivo quel vuoto, che con gli anni si era fatto mano a mano più grande, sfaldarsi come le pietre sotto i miei scarponcini sporchi.
Poi, venne il giorno in cui comprammo due gratta e vinci al bar Achille.
«Tanto, perde’ pe’ perde’, tanto vale che ci risparmiamo il viaggio» disse Mauro. «Che poi se Achille c’ha sfiga, non è che a noi dice tanto meglio.»
E con la moneta cominciò a grattare. Dopo pochi minuti, venne a sedersi accanto a me buttando il gratta e vinci per terra.
«Che merda, manco due dello stesso segno, a te come è andata?»
«La solita sfiga» dissi tenendo ancora stretto il biglietto in tasca. Il fiato corto, le mani sudate. Ci alzammo e ce ne tornammo al paese.
Non so cosa mi spinse a mentire quella sera, né perché nascosi quel biglietto vincente nel cassetto senza parlarne con nessuno per mesi. Forse perché i sogni ci piacciono fino a quando non siamo a un passo dal realizzarli. O magari, perché quel campo minato di cui parlava Achille ci spaventa a tal punto che preferiamo fare finta che non esista, trascorrendo la vita a immaginarlo, senza provare ad attraversarlo mai.
Se c’era uno che quel campo minato l’aveva attraversato più volte, quello era senza dubbio Renzo, il fornaio. Aveva trascorso metà della sua vita al paese e l’altra metà da alcuni parenti emigrati in America da due generazioni. Di giorno veniva al bar con le mani ancora impiastrate di farina e quando pronunciava parole come “whiskey” o “drink” le scandiva sempre; si capiva che lo faceva apposta per far risaltare il suo accento inglese. Diceva che l’America era una merda. Però poi non smetteva mai di parlarne. Alcuni erano annoiati dai suoi racconti, ma per il vuoto che portavo dentro era una manna santa.
Quando le giornate erano troppo pesanti, dopo la chiusura del bar, me ne restavo tutta la notte a guardare le luci delle case nella valle. Mauro in quel periodo aveva preso a lavorare tutti i giorni la mattina presto, domenica compresa, e non c’era più modo di incontrarsi la sera per farsi una birra e andare ai capannoni. Avevamo smesso anche di giocare al gratta e vinci, io per ovvi motivi, Mauro perché s’era rotto le palle di perdere.
Alcuni giorni me ne andavo al forno di Renzo a vederlo fare il pane e ad ascoltare le sue storie. Delle volte, nel bel mezzo di un racconto, Renzo s’interrompeva perché credeva d’avermelo già raccontato. E allora ne pensava un altro e via di lì ricominciava da capo. Per me faceva lo stesso, alla fine. Avevo solo bisogno di un sogno a cui aggrapparmi che non fosse il mio. E di assaporare un po’ di quella vita che tenevo nascosta in un cassetto chiuso. Senza doverla afferrare per davvero.
Achille, un giorno che mi ero incantato a fissare l’entrata del bar con lo sguardo spento, mi prese per il braccio guardandomi negli occhi per un minuto intero. Non l’aveva fatto mai: «Stasera resta a casa. Lavoro io, tu riposa».
«E il tuo appuntamento col destino?»
«Fanculo, il destino.»
Poi tossì e cadde a terra svenuto.
Il fazzoletto sporco di catarro e sangue.
I medici gli diedero pochi mesi.
Da quando Achille si era ammalato, a lavorare con me era subentrata una ragazza di nome Vittoria, che tutti chiamavamo Vicky. Era grassa e aveva i denti storti, ma ai clienti era simpatica. Quando c’era Achille mi toccavano sempre le giornate piene e raramente uscivo dal bar prima del tramonto, anche se lui se ne stava lì seduto da mattina a sera, pure nei giorni in cui rifiutava le mie richieste di riposo, quasi a farmelo apposta. Ora che non c’era, però, nel bar si respirava un’aria strana, e quel vuoto che portavo dentro si era fatto denso al punto che mi sembrava di poterlo sfilacciare con la mano. Il fine settimana andavo a trovarlo spesso. La casa di Achille era l’ultima in cima al paese e puzzava di muffa, o probabilmente era solo lui a puzzare. La gamba di legno poggiata ai bordi del letto, sempre sullo stesso punto.
Gli chiedevo ogni volta se avesse bisogno di qualcosa.
«Manda a cagare la signora Maria da parte mia» e si girava dall’altra parte. Durante quelle ore in mia compagnia, il modo di fare di Achille era sempre lo stesso. Continuava a darmi ordini come se stessi ancora versando birra dietro al bancone del bar e, tra un rimprovero e l’altro, ci buttava in mezzo qualche aneddoto del suo passato. Ogni storia terminava sempre con il racconto di quella mina che, come una calamita di tritolo inesplosa, attirava su di sé ogni finale possibile. In quel periodo in cui andavo a visitare Achille regolarmente, mi resi conto che i suoi occhi vedevano sempre più in là di chiunque altro avessi mai conosciuto, e non erano poche le volte in cui sentivo l’istinto di abbassare i miei, di occhi, quando per troppo tempo li tenevo fissi su di lui, per paura che potesse scorgere quell’insoddisfazione sorda che mi portavo appresso da anni.
«Gli occhi sono come una bottiglia di birra» ripeteva. «Se non li apri, non servono a un cazzo.»
Per capirlo dovevi ascoltarlo bene.
Con il trascorrere delle settimane tornò la primavera. Sbocciarono le viole e le margherite sulla collina. Le api ripresero a ronzare e a fare il miele, e mi divertivo a guardarle immaginando che per loro il mondo era sempre lo stesso, stagione dopo stagione. Non c’erano sogni da inseguire o abbandonare, ambizioni, mondi diversi e lontani con luci sempre accese, grattacieli infiniti, o fazzoletti sporchi di sangue e merda. Nessun biglietto vincente nascosto dentro un cassetto pieno, la voglia di cambiare, la paura di fallire.
Quel pomeriggio incrociai Mauro al bar, non ci scambiavo che un saluto sfuggente da più di due mesi, talmente andava sempre di fretta. Aveva due occhiaie che gli arrivavano ai piedi e la pelle abbronzata aveva ceduto il posto a un pallidume moribondo. Il sorriso che lo caratterizzava si era trasformato in un cruccio triste, che a stento riusciva a mascherare quel vuoto implacabile.
«Domani sera andiamo al capanno?» mi chiese, come se nulla fosse.
«Che fine avevi fatto?»
«Il lavoro» disse mentre si tirava giù la manica per nascondere una serie di buchi sul braccio, regolari e tutti nello stesso punto. Feci finta di niente.
«Domani sera ho il turno, passa dopo mezzanotte.»
«Ricevuto.» Fu l’ultima volta che lo vidi.
Casa di Achille ricordava un’aquila reale che dal punto più alto del paese ne osservava distaccata la storia. È questo quello che pensavo ogni volta, salendo le scale che conducevano all’entrata. Quel giorno le finestre erano aperte, ma la casa puzzava di muffa lo stesso. Achille se ne stava seduto su una sedia nel cortile sul retro e con gli occhi spalancati osservava il tramonto.
«Vie’ vicino» disse, non appena mi sentì arrivare; la testa non la mosse, quel pomeriggio. Nemmeno una volta. Tenne lo sguardo fisso sul sole che calava, con la gamba di legno in grembo e un bicchiere di grappa in mano, semivuoto. Risparmiai le domande sul perché non fosse a letto, o su cosa avrebbe detto il dottore riguardo quel bicchiere che teneva in mano. Mi sedetti accanto a lui, in silenzio, finché indicando la valle non disse: «Ascolta» anche se di rumore non ce n’era alcuno. Tesi l’orecchio, ma non sentii niente
Achille bevve d’un fiato i rimasugli di grappa che giacevano composti sul fondo del bicchiere, poi lasciò cadere la gamba di legno. A contatto col suolo fece un suono duro.
«C’è un momento, in estate, quando il sole cala, che le cicale smettono di cantare e fanno posto ai grilli. L’ho visto, io, quel momento. Co’ gli occhi miei. Quando da bambino me ne stavo fermo su quella mina e per tre giorni c’era solo morte, e fumo, e il rumore degli aeroplani. Ne ho rubato di tempo al destino, da quel giorno, e mo’ glielo ridò indietro, co’ gli interessi, ma prima una cosa te la devo dire.» Le parole erano fioche e alcune si perdevano nella valle, ma chissà come trovavano sempre il modo di tornare indietro. Achille posò il bicchiere e fece un gran respiro, a fatica. Poi, riprese a parlare, e questa volta non smise fino alla fine: «Sbaglia, commetti un passo falso, calpesta una mina. Questo è il mio ultimo consiglio. Sei libero di non ascoltarlo adesso, non sono più il tuo capo, quindi buttalo in un cesso se vuoi, puliscitici il culo, fanne pure quello che ti pare, ma ho visto troppe persone in quel bar che non se lo chiedono nemmeno più se avrebbero potuto attraversarlo quel campo minato, hanno smesso di giocare da tempo, a quel gioco lì. Beh, tu non fare quella fine, giocale tutte le partite che hai davanti, e se perderai, fanculo! Mi hai sentito? Fanculo! Sarà solo un altro sasso nella scarpa, con il tempo non farà più male, ti ci abituerai, diventerà parte di te, come questa gamba di legno che mi porto appresso ormai da anni. Certo farà male, sarà dura, ma la vita, quella vera, ti rimarrà scritta addosso, e non potrai più fare a meno di sentirla picchiare sul serio.
O puoi restare lì dove sei ora, a spillare birra per due spicci di merda, tenendo il tuo futuro come un biglietto della lotteria in un cassetto, e sperando che quella ragazza spunti magicamente dalla porta del bar, prima ancora che tu abbia trovato il coraggio di uscirne».
Tossì nel fazzoletto. Catarro misto a sangue.
Si grattò, fece le corna, e prima di morire disse: «Fanculo la signora Maria». Me lo immaginai che entrava in paradiso con tutte e due i piedi apposto e la gamba di legno sottobraccio: «Lei è il signor Umberto?». Gli chiedevano all’entrata. «Achille, Achille è meglio» e se la rideva, con quel tallone nuovo di zecca, pronto a giocare partite di poker con gli angeli, che ai bluff perlomeno ci cascavano sempre. Qualche partita l’avrebbe vinta lassù. O così, comunque, mi piaceva sperare.
L’autogrill è sporco e odora di benzina.
«Mi piace ’sto odore, quando metti benzina dura sempre troppo poco» Mauro me lo ripeteva spesso quando ci fermavamo al distributore della statale a mettere gasolio nel vecchio furgoncino ammaccato del padre. Io annuivo ridendo, poi mettevo il beccuccio nell’imboccatura del serbatoio.
In America le auto sono grandi, ma le strade ancora di più, e per fare un pieno c’è bisogno di qualche minuto, quindi l’odore te lo godi. Ho scarpe da ginnastica bianche e lavoro sempre in un bar, però qui le persone cambiano ogni giorno e parlano tutte una lingua sconosciuta. Di italiani ne vedo passare spesso; nella maggior parte dei casi faccio finta di niente, per non ingrandire un altro vuoto che nel tempo si è venuto a formare. Di quando vivevo al paese ho solo un’immagine sfocata ormai, però resta chiaro lo sguardo di rimprovero del vecchio Achille, seduto al bar, con la gamba distesa sulla sedia, o il brillare delle stelle nel cielo che guardavo con Mauro, fuori i capannoni, avvolti dal fumo e dall’aroma delle canne. Del gratta e vinci ricordo solo il rumore della carta strappata in due, mentre la corriera macinava l’asfalto in direzione della città, il giorno dopo la morte di Achille. Il mio sguardo che seguiva il naufragare dei pezzi al di là del finestrino, contemplando il loro perdersi nella valle che separava le montagne. Non era più necessario un aiuto del destino, ora che avevo scelto di attraversare quel campo minato l’avrei fatto con le mie sole forze, trattenendo il fiato a ogni passo, attento a dove mettevo i piedi.
Di Carola non mi resta altro che il ricordo vago di una sera d’inverno, e il colore della terra smossa sul fondale. L’ho cercata a lungo nello sguardo di molte donne, in tante parti del mondo, lontane. Ognuna simile a un fiume diverso che faceva sempre lo stesso rumore. E ho imparato a lasciarla andare, ogni volta, come Achille fece cadere a terra la sua gamba di legno, con un tonfo sordo, una volta finita.
Nel frattempo, non troppo lontano, la saracinesca del bar Achille continua a salire e a scendere, di giorno in giorno, da mattina a sera, spinta su e giù da Vicky, o da chi dopo di lei.
Delle volte mi sembra ancora di sentirla quella serranda che sale, e per un po’ la nostalgia mi afferra il cuore, aggrappandosi con gli artigli a quel vuoto sfocato, che di nuovo non mi so spiegare. Immaginando i soliti quattro gatti che se ne stanno ancora lì seduti, a bere birra e a fumare, sputando sopra i giornali con i risultati della domenica sportiva.
Jacopo Ferri
Racconto terzo classificato della sezione A (racconti inediti adulti) del Premio Letterario L’Avvelenata 2021.