Il racconto della domenica: Lenzuola scure di Michela La Grotteria
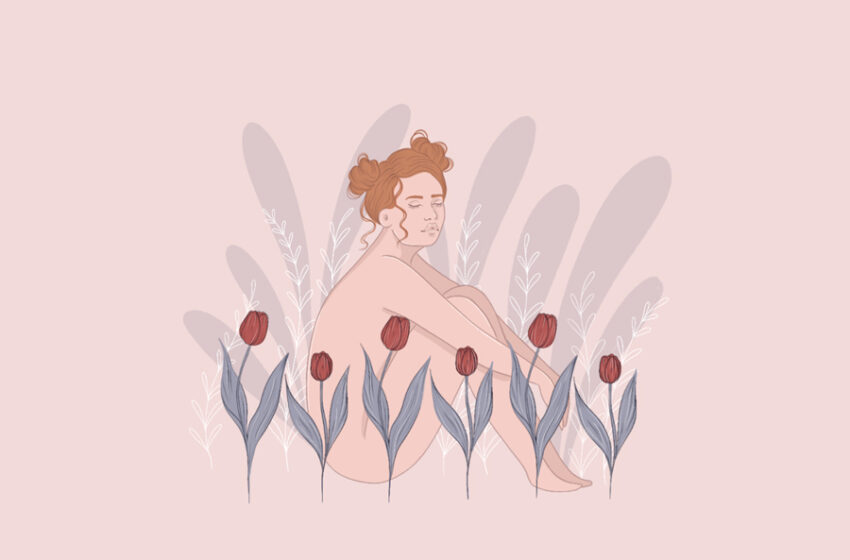
Illustrazione di Sara De Grandis
Quando ho scritto il mio primo racconto, ho faticato un sacco a trovare una storia che meritasse di essere raccontata.
È perché leggi troppi giornali, ha detto Marco. Ti distorce la prospettiva.
E che vorrebbe dire?, gli ho chiesto.
Cerchi di trovare un significato alle storie. Come negli articoli di fondo.
Ma un racconto senza significato è roba da buttare.
Boh, forse. Solo che la vita della gente non ha mica sempre un significato, ecco.
A quel tempo Marco diceva cose del genere. Dipendeva dal master che aveva iniziato a frequentare in Statale: aveva consegne settimanali di elaborati in cui doveva discutere dell’etica della compassione in Edipo re. Quando tornava a casa, verso l’ora di cena, di solito io ero già rientrata: lui mi chiedeva com’era andata la mia giornata, io come stavano i suoi testi morti.
Quel giorno ero seduta a gambe incrociate nel suo letto con un bloc notes sulle caviglie. Indossavo pantaloni a zampa e un reggiseno verde, e tenevo la Bic appesa tra i denti. Ho fantasticato che mi prendesse il blocco dalle gambe e schizzasse il mio ritratto dicendo “dio come sei bella”. Poi mi sono accorta che il tizio che immaginavo non aveva la faccia di Marco. Ho pensato di scrivere di me e lui, mi sono chiesta se in questa storia ci fosse un significato.
L’ho seguito con lo sguardo mentre cercava i vestiti per tutta la camera. Mi divertiva pensare di aver il puzzle completo della sua roba sotto gli occhi, prima che lui ne afferrasse i pezzi: la cintura sul calorifero, il maglione accasciato sullo schienale di una sedia, le Adidas sotto la scrivania.
Se stasera fai tardi, mi ha detto puntandomi con l’indice, ti ammazzo.
Gli ho soffiato un bacio nell’aria, lui ha chiuso la porta alle sue spalle, tamburellando le nocche dall’altra parte come faceva ogni mattina per salutarmi. Mi sono lasciata scivolare lunga sotto il lenzuolo rosso scuro, l’ho tirato fin sopra la fronte. Se avessi dei soldi, ho pensato.
Avevo cominciato a pensare alla ricchezza da quando mi ero trasferita in casa di Marco, vale a dire da quando di soldi non ne avevo più. Mio padre se n’era andato di casa da un paio di mesi quando aveva smesso di versare il bonifico per il mio affitto, come se con la fine del matrimonio fosse compreso anche l’abbandono del suo prodotto. Mia madre mi aveva chiamato una sera per dirmi che non ce la faceva a pagare il monolocale in cui vivevo. Una soluzione si trova, aveva detto, ma tu intanto comincia a cercare qualcos’altro. Mi ero guardata intorno e le pareti del mio appartamento mi erano sembrate espandersi e dissolversi in frammenti di intonaco bianco.
Quando ne avevo parlato a Marco, aveva guardato fisso il bicchiere di birra che avevo davanti. Che puoi venire da me lo sai già, aveva detto. Lo sapevo, e sapevo anche che non era una buona idea vivere a casa di uno a cui piacevo da anni. L’avevo osservato a lungo, fermandomi sugli occhi marroni, i capelli rossastri, il sorriso, come inebetito. Gli avrei fatto un favore a non accettare, ma d’altro canto avevo la certezza che non avrebbe mai approfittato della convivenza per fare la sua mossa: Marco era il tipo di ragazzo che si innamora della sua amica d’infanzia, e poi non ne fa nulla per il terrore di rovinare l’amicizia. Come se fosse una cosa cui la gente dà effettivamente peso, nella vita reale.
Ok, gli avevo risposto, vengo.
Mi prudeva dappertutto, sembrava che un esercito di bestiole stesse marciando sotto i miei vestiti. Marco aveva finito la birra in una sorsata, poi si era messo a far ruotare le chiavi sulla punta del pollice.
Però mi fai pagare l’affitto.
Non se ne parla.
Avevo fatto per alzarmi. Dai aspetta, aveva detto, con un’espressione preoccupata.
Quanto?
Duecento.
Sapevo che non era la cifra reale, ma mi sembrava un buon compromesso, e comunque mia madre non avrebbe potuto permettersi di più. L’appartamento di Marco era un’oasi nel cuore di Milano, io mi ritrovavo spesso a pensare che se avessi abitato in una casa del genere mi sarei fatta consegnare tulipani freschi ogni mattina, da esporre sul balcone.
Ok, gli avevo detto, ok duecento.
Stavo ripensando a quando da piccola, mio padre mi accompagnava in macchina a casa di Marco, spegneva il motore nel suo vialetto e mi scompigliava la frangetta. Diceva, Marco ha tanti tanti soldini. Vedi di giocarci bene oggi pomeriggio, che fra vent’anni te lo puoi accalappiare. Associavo la parola “accalappiare” ai telefilm spagnoli che mia madre guardava a pranzo. Una volta mi sono tolta tutti i vestiti davanti a Marco, come avevo visto fare in uno di quei telefilm, e lui aveva allungato una mano per toccarmi l’ombelico.
Sei morbida, aveva detto. La mano gli tremava e la cosa mi aveva fatto ridere. Era corso fuori dalla sua cameretta, e quando avevo visto che non tornava, mi ero tirata su le mutandine, diligente.
Ho allungato una mano tra le gambe, come mi capitava di fare quando stavo nel letto di Marco. Ho provato a immaginare il sesso tra noi due, un atto aggressivo e rapido. Mi ha dato la sensazione di un rapporto infruttuoso tra animali di due specie diverse. Ero sudata, l’odore delle sue lenzuola mi ha nauseato. Sono scivolata fuori dal letto, ho raccolto i capelli e ho spinto il bloc notes sotto il suo comodino.
Alle sei ho finito le lezioni e sono andata in bici al locale in corso Sempione dove Marco aveva organizzato l’aperitivo. Per strada mi sono fermata a prendergli un regalo in un negozio che sulla vetrina diceva ARTICOLI PER IL COMPLEANNO. Gli ho preso una macchina per fare i popcorn, ma uscendo col pacco tra le braccia mi sono chiesta se mi avesse mai detto di essere allergico al mais.
Mentre posteggiavo la bici, l’ho visto individuarmi e staccarsi dal gruppo per correre verso di me.
Un quarto d’ora di ritardo, ha detto bloccando lo schermo del telefono.
Di eleganza. Serve per la mia entrata in scena.
Si è piegato a stringere la catena tra i raggi della bici, poi ha detto, dai vieni.
I suoi compagni di corso non li avevo ancora incontrati. Mi sono sembrati il tipo di persone che potevano scrivere un saggio sulla teoria cognitiva delle emozioni la mattina, e la sera pagare drink a qualche ragazza per farla ubriacare. Ho provato a sovrapporre quest’immagine a Marco e mi sono morsa l’incavo della bocca.
Lei è Anita, ha detto rivolto al gruppo. Mi è sembrato che mi esponesse come un trofeo e mi ha dato fastidio.
Piacere, ehi ciao, hanno detto voci nel gruppo. Ho notato che non c’erano ragazze e mi ha dato soddisfazione l’essere catalizzatore dell’attenzione di tutti quei maschi.
Siamo rimasti sul pavé del marciapiede per un po’, a dondolarci sui talloni: il tavolo non era ancora pronto. Nessuno di noi sembrava a proprio agio, ma nemmeno del tutto a disagio: stavamo in quel limbo di sobria valutazione da cui ci poteva strappare solo il cenno di un cameriere. Marco mi ha chiesto della mia giornata. Tre lezioni, ne ho seguite solo due, ho litigato con la bibliotecaria e mi sono sporcata la camicia con l’olio dell’insalata di riso. Ha aperto la bocca ed è rimasto un po’ sospeso, poi mi ha pizzicato un fianco e ha detto, te l’avevo detto di prendere il mio Tapper. Aveva uno sguardo che sapeva di burro e marmellata, lo sentii sulle guance come una carezza. Ecco uno che ti vuole un gran bene, mi è venuto da pensare.
Questa è una tua tipica fuoriuscita paternalistica e massivamente oltraggiosa, ho detto.
E questa è una tua tipica fuoriuscita da sborona.
Ho spinto il regalo contro il petto di Marco e ho seguito il cameriere che ci faceva segno. Abbiamo ordinato dei Moscow Mule e spizzicato nella boccia delle noccioline. Nessuno mi considerava granché, ho cominciato a chiedermi cosa pensavano che fossi per Marco. La ragazza? Una tipa che si portava a letto? Una cugina? Ho spostato i gomiti in modo da far scivolare più in basso lo scollo della camicetta, subito qualche paio di occhi si è voltato verso di me.
Marco, ha detto uno.
Eh.
Quindi voi due scopate?
Questo l’ha fatto ridere così forte che ho pensato si stesse strozzando con una nocciolina.
Ma perché?, ha chiesto all’altro.
Dai vivete insieme, tu le paghi l’affitto… mai successo?
Non le pago l’affitto, ha detto Marco. Poi si è girato, mi ha controllato la faccia cercando tracce di sofferenza.
Mi sono alzata con la scusa di non avere campo, dal tavolo si è levato un borbottio di ma certo, scusa eh. Mentre andavo verso l’uscita, ho sentito Marco dire, come se lei fosse un tipo da scoparsi me.
Mi sono allontanata dal locale di qualche passo, ho trovato un rettangolo di asfalto tra due macchine e mi ci sono seduta. Ho tirato fuori una sigaretta moscia dalla borsa. Il fumo saliva agli occhi ed era doloroso: li ho tenuti ben spalancati. Verso la fine della sigaretta ha squillato il telefono. Devo mettere una suoneria che mi invogli a rispondere, ho pensato.
Era mio padre. Ho risposto senza dire niente.
Pulce, ha detto. Non lo sentivo da Natale e la sua voce mi è sembrata torbida, come quella di un convalescente.
Ehi? Pronto?
Sì. Sì, dimmi. Ho spento la sigaretta e l’ho infilata nel tubo di scappamento di un’auto.
Non mi chiami mai, ha detto.
Neanche tu.
È che dormi quando torno a casa dal lavoro, lo sai.
Che vuoi?
Solo parlare. Sentirti. Perché mi aggredisci?
Ho provato a immaginarlo vecchio e sporco, debole, bisognoso delle mie cure. Mi ha fatto pena, e mi sono sentita subito in colpa. Chi offendevo se parlavo al telefono con mio padre?
Ho inspirato a fondo, mi ha fatto male il torace.
Cosa mangi stasera?
L’ho sentito distendersi. Ha detto, piselli e carote in scatola.
Piatto di plastica?
Sempre, così non devo lavare.
La sua risata era calda come un piatto di minestra, cucchiaiate bollenti nella gola di qualcuno in ipotermia. Mi sentivo rassicurata, e mi sono accorta che dipendeva dalla conferma che non c’era un’altra donna in casa con lui: almeno questo, ho pensato, almeno non ha rimpiazzato mamma.
Abbiamo parlato di Milano, del tempo a Novara e della mia nuova bici. Ti ricordi quando ti ho insegnato a pedalare? Ho detto che non me lo ricordavo, ma non era vero.
Non fare troppo tardi, ha detto, non mi piace che torni da sola a casa.
Non torno da sola.
Ah no? Chi ti accompagna?
Marco, ho detto, perplessa.
Chi?
Marco Palmieri.
Quello delle elementari? Non sapevo foste ancora in contatto.
Ho cercato di calcolare come potesse aver rimosso che Marco è stato il mio unico amico ben oltre le elementari.
Sì, ho detto. Mi sono strofinata un dito su un occhio e sono venute via briciole di mascara.
Studia anche lui a Milano?
Papà, abitiamo insieme.
Cosa?
Mamma non te l’ha detto?
È rimasto in silenzio per un po’, io ho fatto lo stesso. Stavamo entrambi pensando a come aggirare l’argomento casa, affitto e soldi.
Ah bene, ha detto. Si è schiarito la voce più volte, come se qualche colpetto di tosse potesse fare ammenda per la sua noncuranza.
State insieme?
No, ho risposto d’impulso.
Capisco. Ha ridacchiato e poi ha aggiunto, beh visto che ci vivi insieme un salto in camera sua puoi farlo.
Ho stretto gli occhi prima di sentirgli dire, cerca di accalappiartelo.
Mi è scivolato di mano il telefono, l’ho lasciato sull’asfalto. Speravo che il tizio della macchina venisse a mettere in moto e frantumasse il telefono con dentro la voce che ripeteva, pronto?pronto?
Quando sono rientrata nel locale, l’atmosfera mi è sembrata più cordiale, come se tutti, anche gli sconosciuti ai tavolini intorno, fossero dispiaciuti della mia lunga assenza.
Ho ripreso il mio posto e ho annuito sorridendo a Marco che mi chiedeva se fosse tutto ok. Non sono riuscita a finire il mio drink, che poi si è scolato uno dei ragazzi.
Siamo tornati a casa in tram, ho detto con un’alzata di spalle che avrei recuperato la bici il giorno dopo. Marco parlava a manetta, e capivo che il suo flusso di parole era un modo per supplire al mio silenzio. Alla nostra fermata si è avviato verso le porte e si è girato a controllare che lo stessi seguendo: lo seguivo. Ci siamo dati la buonanotte sullo zerbino di casa, io ho lasciato cadere la borsa per terra e lui si è tolto la giacca prima di entrare in bagno.
Quando è entrato in camera sua e mi ha vista sdraiata sulle coperte ancora sfatte dal mattino, ha respirato forte dal naso.
Lo sai che lo voglio, ha detto.
Sì. Guardavo i suoi calzini grigi sulle assi del parquet, i quaderni di appunti aperti a pancia in giù Cosa devo fare? Dimmelo tu.
Non ho risposto e lui si è avvicinato.
Perché?,ha chiesto.
Perché non riesco a scrivere il racconto, gli ho detto. Ha sorriso, si è seduto all’altezza del mio bacino. Mi ha passato un dito dalla fronte all’incavo dell’inguine. Quando ha indugiato sui capezzoli, ho trattenuto il fiato. Mi è venuto da vomitare. Non ci sono state carezze, c’è stata invece la brutalità che avevo immaginato. Mi ha risparmiato l’apparato di sfioramenti che me lo avrebbe reso più disgustoso. Si è agitato sul mio corpo per un po’, poi si è rotolato via, verso la parete.
Ti ho appena stuprata?
La sua voce era ancora affannata. E pensare che dipendeva da me, mi ha causato una fitta alla gola.
Gli ho accarezzato una spalla, gli ho detto, se non ti offendi vado a dormire nel mio letto.
Ma certo, ha detto spostando le lenzuola per farmi uscire.
Mi sono chinata per prendere il blocco sotto il suo comodino. Non c’era più.
Michela La Grotteria

















