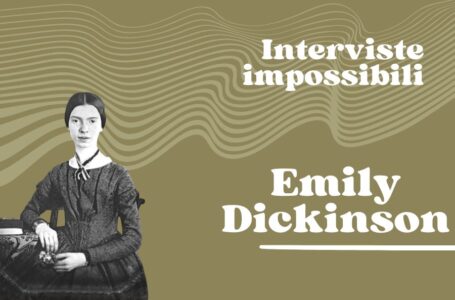Paolo Di Paolo: una vita tra le parole. Intervista allo scrittore

La sua esistenza è stata circondata, fin da bambino, da parole. Ha avuto il privilegio di lavorare con Antonio Tabucchi e oggi è tra le voci più importanti del panorama contemporaneo italiano, tanto da essere, con il suo ultimo romanzo, nella terna finalista del Premio Viareggio-Rèpaci. Parliamo di Paolo Di Paolo, che ci ha raccontato di giornalismo e letteratura, e di quanto ci si possa sentire, talvolta, inadeguati. Buona lettura!
Il 25 aprile hai condiviso la notizia di essere diventato padre. Il tuo ultimo romanzo, Lontano dagli occhi, si costruisce esattamente a partire da questo nucleo: “niente ci accomuna come l’essere figli”. Mi chiedevo: cambia il modo di essere e sentirsi figlio, diventando padre?
Tutto quello che a me è accaduto, in realtà, è accaduto successivamente sia alla scrittura che alla pubblicazione del romanzo. Ma sicuramente questa è una domanda che circola nel libro: ho cercato di capire se c’è una trasformazione; se – come dico nell’incipit – quegli uomini che stanno diventano padri, e che non hanno alcun segno fisico della trasformazione, riescano a maturarla, a un certo punto della loro vita. Questo non significa che smettano di essere figli, ma piuttosto che lo sono in modo diverso: è come se ci fosse un livello aggiuntivo di vita. Da qui parte Lontano dagli occhi. E, per quanto possa risultare ingenuo, credo che sia comunque sconvolgente afferrare questa consapevolezza: cioè che l’essere figli è la cosa che più ci accomuna. Tutto quello che viene dopo – e non mi riferisco solo all’essere genitori, ma anche alle ambizioni a cui si può dare sostanza, ai ruoli che impersoniamo, ai panni che mettiamo, alle storie che viviamo – è come se fosse una serie di elementi in aggiunta a quella verità basica, nuda e biologica che è l’essere figli. Nel mio caso è come se la vita avesse imitato la letteratura, al contrario di quanto accade solitamente. Quando scrivevo non c’era tanto un’urgenza in quella direzione, quanto piuttosto una volontà di interrogarsi. Forse, inconsciamente, nascondeva anche un’avvisaglia, un presagio. O, più semplicemente, una coincidenza.
Retrospettivamente, tu ti riconosci in quei genitori un po’ persi e impreparati di cui racconti nel libro?
Il disorientamento, lo sconcerto e – allo stesso tempo – lo stupore che ho rintracciato in quei personaggi li ho riscoperti, paradossalmente a posteriori, anche nella mia esperienza. Diventare genitore non è una trasformazione banale: è qualcosa che ti porta ad accedere a sentimenti che non avevi mai provato prima, talvolta contrastanti tra loro. Si è necessariamente inadeguati e forse è anche l’unico presupposto per essere genitori: e non perché questo figlio o figlia ti stia chiedendo qualcosa di particolare, ma perché nessuno ci ha preparati ad affrontarlo. Non si tratta, infatti, di dedicarsi semplicemente alla cura pratica di un neonato, ma alla cura di quello che un giorno diventerà un bambino, un ragazzo, infine un adulto. La relazione che esiste tra un genitore e un figlio è qualcosa che, anche solo in senso astratto, nessuno potrà mai cancellare, neanche nelle più turbolente delle dinamiche. Ed è all’interno di questa prospettiva che si capisce quanto quell’elemento di inadeguatezza rimanga attivo per tutto il percorso genitoriale. Si può imparare a cambiare un pannolino, ma quand’è che si impara a gestire i sentimenti e gli stati d’animo di un essere umano che non sei tu?
Questa impreparazione di cui parlavamo è una sorta di filo rosso che guida le esistenze che descrivi: si tratta generalmente di personaggi instabili, non del tutto adeguati alla vita in cui si trovano immersi. Li segui con occhio partecipato, raccontandone le fragilità e i momenti di presa di coscienza. C’è un motivo dietro questa scelta? È questa l’umanità che vedi attorno a te o è così che percepisci il tuo essere uomo?
Entrambe le cose. Tutti i personaggi che ho raccontato hanno un buco, qualcosa che non funziona. Questa è probabilmente una caratteristica degli esseri umani in generale. Come persona e come scrittore mi sento sempre un po’ incuriosito da quello che non va, da ciò che non collima rispetto a un’apparenza di disinvoltura. In un certo senso, è come se non avessi mai perso di vista il Lucien di Raccontami la notte in cui sono nato, uno dei miei primi romanzi. Tutti i personaggi che ho descritto hanno, in modo diverso, la sua stessa difficoltà nel sincronizzarsi con quella facilità che lui avverte nel modo in cui gli altri vivono i rapporti umani. E probabilmente non è totalmente un caso che si tratti sempre di personaggi giovani, anche se a età diverse. Credo che nell’adolescenza – nel suo senso più etimologico, cioè adulesco, crescere – ci sia una materia narrativa infinita. È qui che mi piace intercettare ciò che non funziona, ciò che è inadeguato. Probabilmente anche perché le cose che ho sentito, le ho sempre sentite in una forma eccentrica rispetto agli altri, in un tempo di solitudine. Da questa esperienza è iniziata la mia ricerca, quella che nel tempo mi ha spinto a leggere e, successivamente, a scrivere.
La tua vita infatti è circondata da parole: le scrivi, sui giornali e nei libri; le racconti, a Radio Tre, nel programma La lingua batte; le leggi fin da bambino. Come si è sviluppata questa affinità?
Il rapporto con le parole è talmente sorgivo e misterioso, per me, che è anche difficile pensarmi senza di esse. Questa dimensione è stata fin dalla tarda infanzia il mio spazio: in un primo momento in senso visivo, con i fumetti; poi attraverso le parole. Leggevo e scrivevo, senza alcuna destinazione, quasi come se stessi coltivando un gioco tardivo. E, con uno sguardo retrospettivo, posso dire che è come se non avessi mai smesso di portare avanti quel gioco. A un certo punto questo rapporto è diventato anche un lavoro: ho iniziato a scrivere per i giornali, ho pubblicato i miei primi romanzi. Poi è venuto La lingua batte, che mi consente di avere un rapporto con la contemporaneità del linguaggio e con la possibilità di applicare una prospettiva linguistica a tanti temi diversi: la politica, la canzone, il coraggio. Tutto ciò avviene attraverso la porta delle parole, che è un mondo che conosco talmente bene da sentirlo sicuro, mio. In fondo non c’è alcun’altra cosa che ci distingua più clamorosamente dagli altri animali se non questa forma particolare di comunicazione che abbiamo, la stessa che ci permette di trasformare in un lessico e in una sintassi anche qualcosa di impalpabile, come un sentimento.
Negli anni hai raccontato la tua passione da lettore per Antonio Tabucchi, Italo Calvino, Lalla Romano, Elsa Morante – solo per citarne alcuni. È anche uscito di recente un testo per Laterza, a proposito (Vite che sono la tua). Mi chiedo, a questo punto: da dove è passato invece il tuo apprendistato da scrittore? Cosa ha formato la tua voce? E soprattutto: come l’hai trovata, tu, la tua voce?
Sicuramente quando ho iniziato a scrivere seriamente narrativa, a diciannove anni, ho seguito per lo più un principio imitativo. Il mio esordio – Nuovi cieli, nuove carte – è stato proprio un tentativo di trovare una voce a partire da esperimenti d’imitazione. Era un modo di mettere alla prova la mia scrittura. Poi, pian piano, credo di aver trovato un mio timbro, che probabilmente risente di alcuni scrittori più che di altri. È inevitabile che ciò che leggiamo – e che abbiamo letto – funzioni come materia di confronto costante, di ripensamento. Ma c’è anche dell’altro. In un certo senso, mettersi a scrivere un nuovo libro è sempre un po’ come ricominciare da capo, come rimettere in gioco tutto ciò che si conosce riguardo alla scrittura. E probabilmente anche le esperienze che sembrano laterali inevitabilmente innervano la tua voce e le danno ulteriori possibilità. Quando ho scritto Una storia quasi solo d’amore, un libro in cui si parla anche di teatro, stavo facendo parallelamente un’esperienza di questo tipo. E non è un caso. Truman Capote scriveva, a proposito, nella prefazione di Musica per camaleonti, che la scrittura somiglia alla tastiera di un pianoforte: ogni scrittore dovrebbe saper suonare tutte le musiche per saper scegliere quale adoperare. A me sembra di aver fatto, in questi anni, un lavoro in questo senso, che non si è mai ritratto di fronte a nessun tipo di scrittura, neanche davanti a quelle che potevano sembrare le più aliene rispetto a quella destinata alla narrativa.
Sei stato, qualche anno fa, candidato al Premio Strega con “Mandami tanta vita”. Tu cosa ne pensi dei premi letterari?
Un premio letterario nella vita di uno scrittore generalmente è sempre ben accetto, soprattutto quando – come nel caso dello Strega – aiuta a dare luce a un libro. Ma, come diceva recentemente Stefano Petrocchi (il direttore della Fondazione Bellonci) un premio non istituisce un valore imperituro. È la lettura dei posteri a fare la differenza. Nel presente, invece, è una grande occasione. Se io non avessi avuto la fortuna di essere in finale, nello stesso anno, al Premio Campiello Giovani e al Premio Calvino, probabilmente non avrei avuto la fiducia necessaria a azzardare, ad investire emotivamente e intellettualmente sulla mia passione. E non perché si tratta del sigillo di un valore estetico indiscutibile, ma perché improvvisamente avevo ricevuto quel riscontro esterno che, forse, mi serviva per continuare.
Ci sono delle pagine, alla fine di Lontano dagli occhi, che raccontano i primi, timidi, passi nel mondo del giornalismo. In particolare, a un certo punto racconti dei consigli che ti furono rivolti da chi era nel mestiere. A parti invertite, tu che consigli daresti a un aspirante giornalista?
Intanto direi che il consiglio che posso dare oggi è diverso da quello che avrei potuto dare in passato e da quello che potrei dare in futuro. Il paesaggio complessivo dell’informazione e del racconto giornalistico sta cambiando con una velocità che nel secolo scorso sarebbe stata inimmaginabile. Basti pensare al fatto che il modello televisivo non è più unico; pian piano è stato defenestrato dal modello di informazione online, che ancora però non ha strutturato fin in fondo l’informazione; i giornali cartacei sono ormai in crisi. Quindi, probabilmente, l’unico consiglio onesto che potrei dare è quello di non pensarsi come giornalisti di carta stampata, di televisione o di web, ma come persone capaci di modellare il racconto giornalistico sulla singola piattaforma. La cosa più avventurosa che qualcuno può fare, oggi, è un esercizio di duttilità a partire dalla propria narrazione e dal proprio timbro. E non vale solo per il mondo del giornalismo, ma anche per quello della scrittura. Se c’è una cosa che mi affascina, ultimamente, è proprio l’idea di poter costruire un racconto per tappe: partire da un podcast per arrivare a un libro, per esempio (penso all’esperimento che ha fatto Michela Murgia con Morgana).
Concludo così, con una domanda che credo si faccia ogni giorno più urgente: qual è il senso della letteratura, oggi?
È una domanda impegnativa, a cui è complicato rispondere senza essere retorici o enfatici. Però è una domanda che è importante farsi, proprio per il suo essere tanto radicale e eterna. È come se porsela significhi già mettersi alla ricerca di un senso.
Negli ultimi decenni il romanzo ha risentito sicuramente moltissimo della concorrenza di altri arti narrative (cinema in testa, serialità televisiva e via dicendo). L’alternativa che io propongo è quella che fonda e scommette tutto quello che può sul linguaggio. Scrivere significa questo: scegliere delle parole, metterle insieme, e farle esistere in quella relazione stringente tra lessico e sintassi. E per quanto sia banale e immediato, è comunque sconvolgente che, nel momento stesso in cui io metto anche solo un punto, questa piccola trasformazione determini – o non determini – una sensazione in chi legge. Può essere tristezza, fastidio, coinvolgimento, commozione – ma non esisterebbe senza quella scommessa di cui parlavamo prima. Un libro si costruisce su questa unica materia: ti trovi davanti a duecento pagine riempite soltanto di parole, ma è in quella sequenza che hai visto una persona, hai ripescato un ricordo, hai sentito un dolore. E allora il senso della letteratura, oggi, è tutto qui: nel tenere solida questa possibilità e non disperderla, a prescindere da quanto sia grande la comunità dei lettori.
a cura di Rebecca Molea