Uvaspina di Monica Acito: l’arte di vivere tra estro e imitazione in un romanzo d’esordio. Recensione
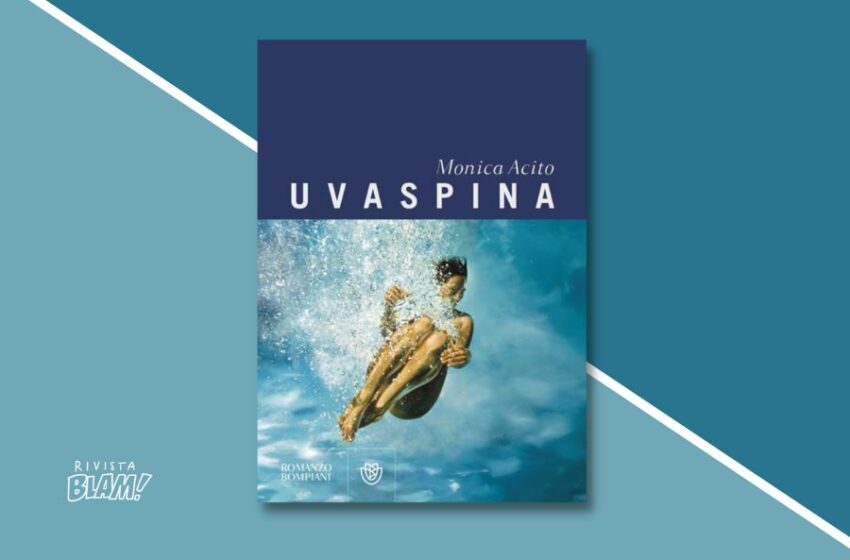
L’uvaspina è un frutto, si dice, il cui succo è capace di curare ogni tipo di malanno. Nel suo romanzo d’esordio (Bompiani, 2023) Monica Acito – già vincitrice del premio Calvino 2021 per la narrativa breve – da quel frutto spreme l’essenza del personaggio protagonista che, non a caso, porta il nome del piccolo ribes. Una storia familiare che è una riflessione sull’arte di vivere: tra gioco delle parti e improvvisazione. Il senso di possessione magica che permea le pagine incanta il lettore e lo trascina in un viaggio nel cuore della Napoli, divina e diabolica, cantata da Pino Daniele.
Uvaspina di Monica Acito: la trama del libro
La storia della famiglia Riccio ha inizio in una chiesa, dove tutto comincia e tutto è destinato a finire. In chiesa Graziella la Spaiata con la sua arte di «chiagnazzara» (la prefica che piange per soldi ai funerali degli altri) conquista il cuore di Pasquale, notaio e presidente del Circolo nautico di Posillipo. Dal loro amore impetuoso nascono due bambini, Uvaspina e Minuccia: così simili da sembrare gemelli, così diversi da diventare vittima e carnefice, in una casa dove tutto resiste in un equilibrio precario e posticcio.
Uvaspina è il primogenito della famiglia Riccio, dai capelli scuri e la pelle chiarissima, con una voglia sotto l’occhio che ricorda il frutto da cui viene il suo soprannome. La sua indole docile e gentile gli impedisce di contestare la madre quando gli chiede di stare in disparte o di reagire ai continui soprusi della sorella che lo chiama «femminiello» come i suoi compagni di scuola.
Minuccia, invece, intimidisce qualsiasi interlocutore con il suo impeto travolgente che la fa sembrare uno «strummolo»: una trottola di legno che trascina con sé ogni cosa che incontra. Lei intuisce i sogni e i segreti di Uvaspina, e approfitta della ritrosia del fratello per schiacciarlo, spolparlo e ridurlo a un’ombra, in un sadico esercizio del potere.
Sarà l’incontro con Antonio, il pescatore dagli occhi eterocromi, a rendere Uvaspina più sicuro di sé, e attraverso un’iniziazione all’amore e alla sessualità, a fargli sperimentare la passione e il desiderio di riconoscersi in una vita migliore. Ma a Napoli non c’è destino, sembra, che non sia legato, alla cordicella di uno strummolo che gira senza sosta.
L’arte di «chiagnere e fottere»
Ogni personaggio nel racconto di Monica Acito è tragicamente destinato a interpretare un ruolo assegnatoli dal destino. Nessuno, anche volendo, può esimersi dall’indossare la maschera che è stata scelta per lui e per questo la famiglia Riccio non può essere se non ciò che è: l’abbraccio affettato tra un’uvaspina, uno strummolo, una «malafemmena» e uno «scuorno».
Nonostante le «tarantelle» che ogni personaggio vive nel quotidiano, è impossibile scardinare il gioco delle parti se non sposando l’arte del «chiagnere e fottere», che, nel suo fondere insieme verità e imitazione, è la cosa più simile alla libertà. Del resto, tra i vicoli e i castelli di Napoli, con il sottofondo delle onde del mare increspato «uno non può fare altro che inventarsi un po’ di allegria per campare e trovare qualcosa di buono pure là in mezzo».
La scrittura di Monica Acito in Uvaspina
Monica Acito trasporta il lettore in una città circense, aspra e dolcissima, sguaiata e sospirante. La sua scrittura viscerale affonda nel ventre di Napoli come nell’intimità dei personaggi, attraverso un impasto linguistico che mescola italiano regionale, espressioni dialettali e lingua standard. Acito ha giocato con stereotipi e archetipi riuscendo a rielaborare un mito antico di sopruso e riscatto.
A cura di Sara Gasperini











