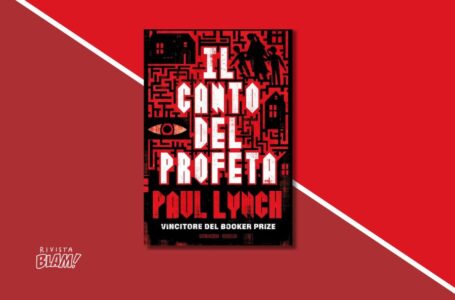L’insignificanza del maggiolino: un racconto di Benedetta Barone

Illustrazione di Valentina Cascio
Furono anni strani. Una domenica di giugno mi infilai in un taxi e diedi l’indirizzo di un ristorante in collina. Mi aspettavo una campagna verde, disabitata, sulla quale mi sarei stesa con la bocca spalancata, a ricevere i raggi del sole fin dentro la trachea e poi tornare a casa con l’incarnato di una contadina. Invece, la macchina mi lasciò a metà di una strada urbana in salita e a sinistra l’insegna dell’agriturismo penzolava all’ingresso di un cortile pieno di tavoli rivestiti di tovaglie di fiandra.
A Torino dove cominciano gli alberi? Non l’ho mai saputo. La città, anche se è cinta dai promontori, allunga i suoi bracci con robotica ostinazione, si dilata e si espande, punzecchia lo sguardo, non tace, non si arrende, non si rassegna a finire.
Così pranzai sotto a un pergolato e beccai come una gallina nell’orto i piatti che mi portarono. Ricordo che, alla fine, una signora di cui non riesco a visualizzare il volto neppure se mi sforzo, perché non possiedo la virtù dell’osservatore sistematico dei lineamenti umani – mi attraversano lo sguardo e poi mi abbandonano –, arrancò fino a una sedia e cominciò a fissarmi. Aveva le gambe gonfie, questo sì, e i capelli ingrigiti raccolti sulla nuca, e si faceva aria con un ventaglio.
A un certo punto, indicò con un dito il posto accanto a lei. Mi domandò perché fossi lì da sola. Si impietosì, ma non ne aveva motivo, perché non c’è nulla che io amo e proteggo di più dello spazio inviolato e sigillato della mia invisibilità. Però le raccontai lo stesso che soffrivo, perché amavo una persona che non stava più con me. Le dissi anche che non ero di quelle parti, che mi ero trasferita a Torino per studiare, che la mia famiglia si trovava ancora a Milano, gli amici erano già tutti partiti per le vacanze, sì, in effetti non avevo nessuno. Lei mi cullò, mi coccolò, mi raccontò delle nipoti, dei loro fidanzati. Parlammo a lungo dell’amore. Si chinò verso di me e sospirò: «Tornerà, si fidi. Tornerà da lei. Ma a quel punto sarà lei a non esserci più». Mi riposai su quel ciglio inatteso, annuii, sorrisi, socchiusi gli occhi. Mi telefonò qualche volta nei giorni successivi, per sapere come stavo. Una volta mi passò la nipote: una voce squillante sillabò il mio nome. «Be-ne-detta». Mi chiese se volevo uscire a prendere un gelato.
Dopodiché, smisi del tutto di risponderle.
La verità è che ero felice. La nostalgia per la persona che non stava più con me creava scompiglio, mi sentivo graffiata in pieno volto da una zampata feroce e improvvisa; avvertivo l’incuria della disperazione anche solo aspirando l’odore della sera quando chiudevo gli scuri delle finestre prima di andare a letto.
Ma era estate. All’orizzonte si annunciavano baldorie, stati d’animo disordinati, avrei baciato con la lingua, ballato a piedi scalzi, sì, senz’altro, producevo fantasie con l’entusiasmo ostinato che mi coglie in fasi circoscritte della mia vita e mi rapisce, mi ottunde i sensi: il bacino mi si sospinge in avanti e io esisto così, le gambe a penzoloni, a strapiombo sul mondo.
Non mi interessava dove avrei lavorato, se avrei infine scritto il mio libro, se stessi o meno covando una gravidanza creativa. Non mi sentivo feconda, non volevo il ventre gonfio. Ero sterile e asciutta come una ragazzina. Nel mio destino si accavallavano soltanto le prossime settimane, i prossimi mesi.
Desideravo il fumo della locomotiva. Semplicemente vederlo, registrarlo, guardare passare il treno restando sulla banchina.
Non ero certa di nulla.
Passeggiavo. Entravo in tutti i bar del centro e delle periferie. Quel giorno, nella calura faticosa del primo pomeriggio, percorsi a ritroso il tragitto dal ristorante fino alla scacchiera delle vie del centro, scivolando lungo pendii asfaltati, leggera e insignificante come un maggiolino.
Fotografavo capannelli di anziani in sosta davanti ai muri di mattoni di Santa Giulia. Gruppi di querule signore sedute ai tavoli di un caffè con le pale del ventilatore a scuotere appena la panna montata dei loro capelli.
Bighellonavo. Controllavo gli orari del cinema, correvo per non perdere l’ultimo spettacolo, entravo in sala col fiatone, durante le pubblicità iniziali aprivo il libro e leggevo alla luce intermittente dello schermo.
Compravo la cena e leggevo a ridosso dei muri aspettando che mi chiamassero per la consegna.
Dormivo tanto.
Certe mattine mi ricordavano le partenze per il mare di quando ero bambina: i bagagli accatastati alla porta, lo stato d’animo fatuo che si accompagnava alla stagione, la premonizione dell’estate che infine incomincia e perdura, le cose che si verificano dopo averle a lungo desiderate.
Sognavo poco o affatto, al risveglio ero intorpidita dal riverbero di alcune immagini che poi puntualmente si dissolvevano.
Torino per me rappresentava questo. Non avrei mai permesso che si intrufolassero tra le pieghe di quell’incanto. Si intrufolassero, chi? Ma tutti, chi. Tutti. Gli altri. Chiunque volesse costringermi a un dialogo, a riflettermi in occhi acquosi e distratti, chiunque mi imponesse di sporcarmi la bocca di fumo, di vino, di conversazioni sguaiate, che mi scoprono le anche come l’elastico troppo molle di una mutanda.
A Milano mi tormentavo, salivo e scendevo dai tram. Trangugiavo bicchieri, giù, giù, giù, la pelle nuda delle cosce si incollava ai sedili freddi degli autobus, alle panche dei ristoranti, non mangiavo niente e la mattina mi alzavo dopo un sonno stiracchiato che mi lasciava soltanto poche ore di ricognizione, poi di nuovo a pizzicarmi le guance, a rinvigorirmi la carnagione stendendo pennellate di fondotinta come su un muro di calce fresca. Mi stordivo del mio stesso profumo, persistente, acre, che mi davo prima di uscire e restava ad aleggiarmi sui capelli e sui vestiti anche dopo la notte, dopo la doccia.
A Torino, invece, esistevo appena. Esistevo vagamente. La mia presenza si sfilacciava e si ritorceva, si annodava a esperienze concrete, al supporto di oggetti, perché solo così riprendevo forma e colore.
Avrei potuto essere giovane o vecchia, non aveva importanza.
Spingevo la bicicletta oltre il portone, tentavo di incastrarla in mezzo alle altre nel mio cortile costeggiato di sanpietrini; quella sferragliava, il manubrio si inclinava a destra come un cavallo che volta la testa perché rifiuta di farsi imbrigliare. Mi scappava così tanto la pipì che qualche volta succedeva che mi accucciavo lì, sotto le finestre del primo piano, i pantaloni alle caviglie, un lungo suono di torrente sottile.
Quel principio d’estate andò così.
Capitava anche che piangessi. Le lacrime somigliavano a frecce argentate, piccole e aguzze; neanche erano capaci di tuffarsi al di là delle palpebre, restavano impigliate tra le ciglia, mi solleticavano gli occhi. Allora cercavo la mamma. Mandavo lunghi audio alle mie amiche.
Aveva ragione la signora dell’agriturismo. La persona che amavo e che non stava più con me poi è tornata. Nel frattempo molto era stato consumato, interrotto, invertito. Però non era vero che io non ci sarei stata più. C’ero.
Benedetta Barone