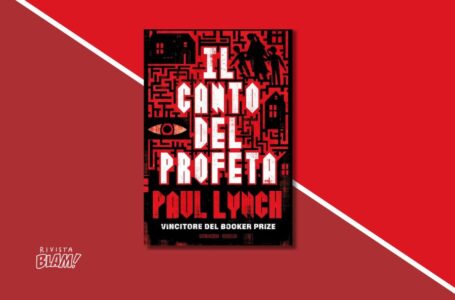Il racconto della domenica: La prima volta di Chiara Bertora

Illustrazione di Mari Madeo
La prima volta me la ricordo benissimo.
La prima volta che mi hanno marchiato.
Allora non ero in grado di capirlo. Avevo delle speranze che erano sane, belle, pulite. Consideravo di avere qualche buona possibilità di imparare questo mestiere. E poi volevo un posto di lavoro, fantasticavo di poterlo dire agli zii di Roma a pranzo dalla nonna, e magari anche quando mi sarei presentato a una ragazza, quando ancora ne incontravo qualcuna fuori da Tinder.
Stamattina li ho visti, quelli nuovi, mentre aspettavano davanti alla sala della prova di selezione. Saranno stati una quarantina, per diciassette nuovi tirocini. Parlottavano fitto tra loro a piccoli gruppi fluidi che si scomponevano e ricomponevano a flusso ininterrotto. Ho giocato a immaginare i fili secondo cui si muovevano. Alcuni avranno studiato insieme, altri hanno fatto forse già uno stage nello stesso ufficio. E poi, qualche passo più in là, ognuno per conto suo, gli esterni. Quelli che sono venuti da lontano, con un sogno ancora più intatto.
Li ho osservati per un po’ dalla finestra del mio ufficio, quassù, finché non sono entrati nella sala per il rito di iniziazione. La loro prima volta.
All’inizio tu credi che sarai scelto perché hai le caratteristiche per potercela fare. Sei brillante, promettente. Quello che ancora non sai è che sei una pedina su una scacchiera e saranno loro a muoverti. Non importa se sei pedone, torre, o cavallo. Potresti avere anche la stoffa del re, ma sarai sempre spostato, spinto o protetto da loro, le mani grandi che ti muovono, a volte ti difendono, altre ti espongono a essere eliminato.
Mio fratello una volta, parlando di un suo amico che era diventato direttore di una filiale a meno di quarant’anni, mi ha detto: «Prima o poi quelli veramente in gamba ce la fanno». E io ho desiderato di farcela – cazzo se l’ho desiderato! –, volevo che la gente, parlando del più e del meno, quando gli venivo in mente io, dicesse una corsa così: ti ricordi di Lucio, quello che pigliava sempre cinque in disegno e non parlava mai con nessuno, mica ce n’eravamo accorti ma è uno davvero bravo.
Tra qualche ora ci sarà l’ultimo colloquio per un’assunzione a tempo indeterminato. Erano dieci anni che lo aspettavo. Le mani grandi che governano la scacchiera l’han già reso il “mio” posto a tempo indeterminato. Ma c’è una cosa che quelle mani enormi e maligne non sanno ancora: una settimana fa ho deciso che oggi non ci andrò al colloquio. Non l’ho ancora detto a nessuno. Chiudo gli occhi, mi lascio attraversare dalla sensazione di poter essere pensato come uno davvero bravo. Voglio che mi esca dalle narici, dagli occhi, dalle orecchie, da ogni singolo poro della pelle. Che si allontani per sempre. Non è da loro che voglio essere pensato come bravo.
Mi torna in mente il viso di quell’esterno che mi aveva chiesto, prima del mio e suo esame per entrare in tirocinio, come questo si sarebbe svolto. Eravamo proprio lì nello stesso cortile dove stanno aspettando adesso i nuovi arrivati. Io sapevo già tutto qualche giorno prima, conoscevo le domande e avevo imparato a memoria la successione delle risposte. A, a, d, e, f, b, c, c, c, a, b, f, e. Ma me ne sono stato zitto, gli ho semplicemente risposto che avevo letto sul sito che la prima prova sarebbe stato un test a crocette. Avevo una paura fottuta di essere spazzato via dalla scacchiera. È stato proprio quello, il momento: mentre rispondevo con parole vaghe a quella domanda precisa, la pelle ha cominciato a bruciare. Ho cominciato a diventare come loro.
Ci saranno altri tre candidati a partecipare al colloquio finale per l’assunzione a tempo indeterminato. Il dottor Candidi, il direttore del personale, me lo ha già detto da tempo. Arriverà anche una ragazza da un’altra sede, con un curriculum pazzesco. Ha seguito progetti all’estero, ha vinto dei finanziamenti importanti, ha pubblicato dei manuali tecnici. È lei quella veramente in gamba per questo lavoro.
Candidi mi ha detto che a lui non interessa tanto quello che si legge nelle righe del curriculum, loro sanno che io sono uno che sa comportarsi, di cui ci si può fidare. Mi ha convocato nel suo ufficio, una sera. Ha chiuso la porta. Mi ha detto che avremmo dovuto lavorare insieme per capire come fare fuori quella dell’altra sede. Alla fine abbiamo trovato il modo, anzi sono stato io a trovarlo. Di nuovo questa maledetta nausea, devo aprire la finestra. Candidi ha detto che, una volta che avrò vinto io il posto, se lei proverà a presentare lamentele formali in direzione centrale, tireremo fuori quelle foto per farla tacere, quel bel culetto al sole così poco professionale. Il giorno che le ho trovate in rete, Candidi mi ha offerto persino il caffè. Era soddisfatto di me. Mi ha detto che di me ci si può fidare. Di me, che faccio schifo come loro. Però mi dico che almeno non gliele ho date, quelle foto. L’altra sera le ho telefonato, ho fatto pure la figura dello stalker. Le ho detto di toglierle da Instagram e ora quelle foto non sono più in rete, alla portata di Candidi.
Giuliana, la mia collega di scrivania, l’altra settimana, così di punto in bianco, mi ha detto che sono una persona di merda. Ho vomitato lì, in ufficio davanti a lei, almeno sono arrivato al cestino. È da tanto che non siamo più così amici, da quando loro hanno scelto di fare andare aventi me e lei no. È solo invidiosa, mi dicevo, perché lei, a differenza mia, non ce la farà mai a entrare tra quelli che contano. Quando avrà finito il tirocinio, avrà trentadue anni e un marito. La manderanno via. Se fosse lei al mio posto, ne ero convinto, non si comporterebbe diversamente da me, non potrebbe: la posta in gioco è troppo alta. Mentre me ne stavo lì a lavare il cestino col vomito, lei mi ha seguito nel bagno degli uomini, mi ha detto che sono solo io che posso decidere per me, che posso ribellarmi alle regole meschine di questo posto. «Sei una poveretta» le ho detto, «che altro posto potrebbe essere migliore di questo, lo dicono sempre i dirigenti. La scacchiera è prestigiosa, lo sappiamo tutti.» Le ho detto così e, mentre parlavo e l’acqua aperta lavava il cestino, mi sono girato verso lo specchio, solo per un attimo. Mi sono visto. Avrei voluto continuare, dirle che una volta che sei dentro puoi cambiare le cose, che avrei avuto il potere per fare delle cose importanti. Ma le parole non sono più uscite, sono morte lì.
La settimana scorsa Candidi mi ha anche detto che, una volta vinto il posto, mi porterà a cercare funghi con lui. Dice sempre che lui non li mangia per via dei calcoli alla cistifellea, ma va a raccoglierli prima che arrivino a prenderli quelli che non sono della sua valle. I forestieri, li chiama, con disprezzo. La sera prima non va a dormire, aspetta in auto fino verso alle tre del mattino e poi parte con la pila frontale, va in posti che conosce solo lui e prende tutto quello che trova. Ritorna a casa che non sono ancora le sei, prima che arrivino i forestieri a rubare nei boschi. Di funghi in ufficio non ne ha mai portato neanche uno, li vende.
Improvvisamente mi sento soffocare, oggi fa davvero caldo per essere autunno. Ho di nuovo nausea. Sono settimane che mi sveglio così, non riesco a digerire più niente. Forse è meglio che esca a fare due passi. Parlerò più tardi con Candidi per informarlo che non ci sarò al colloquio, che oggi sono venuto per firmare il foglio di dimissioni. È stato pazzesco riuscire a farlo. La segretaria mi ha chiesto se per caso mi sentissi male e sì, era vero, stavo malissimo, ma anche benissimo insieme, come le radici di un albero che riescono a farsi strada nel cemento e prima lo crepano da dentro, poi lo squarciano. Il legno delle radici si rovina per riuscirci, ma è il prezzo che pagano per liberarsi.
Non appena metto piede fuori dall’edificio mi sento strano, non mi ero accorto che fosse una bella giornata, l’aria è tiepida, le foglie rosse e gialle degli aceri ondeggiano lentamente. Starò fuori al massimo mezzora, mi dico. Nel parcheggio ho visto che c’è già l’auto di Candidi. Ha le ruote sporche di fango, mi sa che stamattina è di nuovo andato a funghi.
Mi avvio verso il cancello principale, spero di non dovermi fermare a parlare con qualcuno. Ho fatto bene a uscire, la nausea se ne sta andando. All’improvviso mi sento meglio, anzi mi sento bene, mi sembra di non essere uscito da mesi, da anni. Anzi, mi chiedo se sono mai stato fuori prima d’ora. Imbocco il viale alberato che dalla zona industriale porta verso il centro della città.
L’aria è piacevole, mi viene voglia di camminare. Tolgo la giacca, la poso su una panchina, non voglio pesi. Mi dico che la riprenderò tra pochi minuti, tornando indietro. Il sole caldo di stamattina è così rassicurante che inizio a correre. Non so cosa mi prende, non riesco a resistere. Prendo velocità, fino a che non comincia il fiatone. Allora rallento un po’. Comincio a saltare. E poi a gridare. Fortuna che non c’è nessuno in giro. Quasi non me ne accorgo e mi ritrovo vicino al fiume.
Sbottono la camicia, tiro su le maniche. L’aria mi accarezza la pelle, è fresca.
Mi accorgo di aver lasciato il cellulare nella tasca della giacca, non ho nemmeno l’orologio, chissà che ore sono. Comincio a passeggiare sul lungo fiume. Mi fermo sul parapetto, mi sporgo a guardare l’acqua. Il riflesso del sole mi costringe a chiudere gli occhi. Sento il cuore battermi forte nel petto, rimbomba fin su dentro alle orecchie. All’improvviso arriva un pensiero, come un bagliore sotto le palpebre: sono libero. Mi siederò nel dehor di un chiosco sul fiume, aspetterò lì che venga pomeriggio.
Chiara Bertora