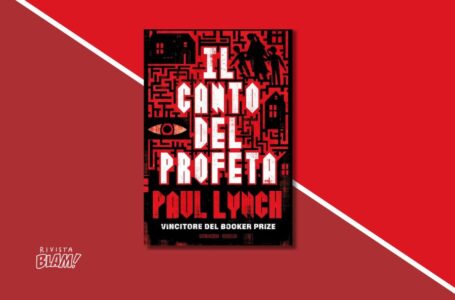Il racconto della domenica: I tre cuori dei polpi di Margherita Seppi
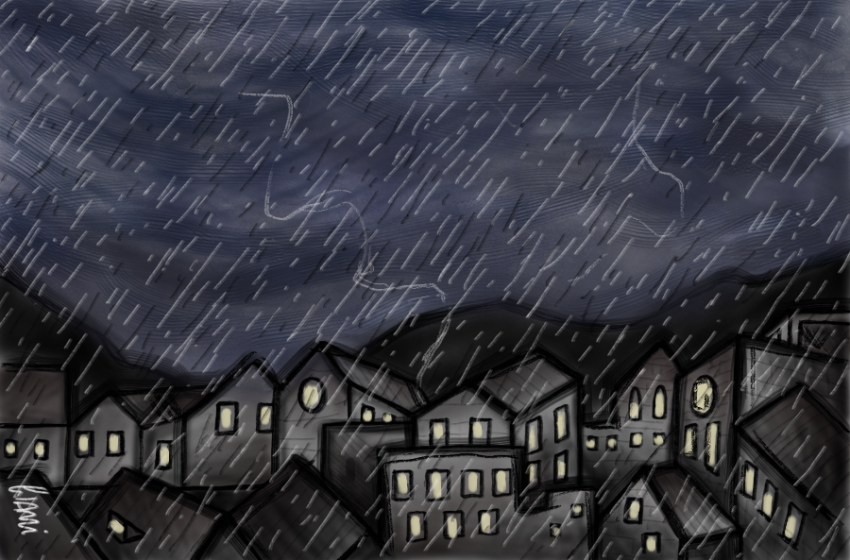
Illustrazione di Gianni Somigli
Fu l’estate dei temporali violenti: scoppiavano inaspettatamente, ti prendevano di spalle e ti scagliavano addosso una pioggia tagliente, cattiva, che pungeva la carne come migliaia di coltelli affilati.
Fu l’estate di Andrea, dei suoi occhi trasparenti come l’acqua, e del giorno in cui lo trovarono con la faccia in giù in una pozzanghera, appena dopo la fine di un nubifragio.
Fu anche l’estate dei roghi alle streghe e delle iniziazioni, dell’innocenza perduta e lanciata in pasto ai leoni.
Quell’estate io avevo 18 anni e fu l’ultima che trascorsi a casa. Me ne andai alla fine di settembre, quando il tempo, come il paese, era tornato mansueto e quieto, del colore delle foglie che ingiallivano sui tigli. Mentre aspettavo l’autobus che mi avrebbe portato in città, rivedevo il momento in cui, quattro mesi prima, in quello stesso punto, Andrea arrivava.
Io ero al baretto della stazione e stavo là, credo, da dieci ore filate. Parlavo con Giulio, che aveva appena buttato un pizzico di molly nelle birre; la Fede invece si era addormentata con la fronte sul tavolo e le braccia cascanti in una posizione che non so se mi faceva più tenerezza o pena. Lei beveva e basta. «Non voglio mica diventare scema» mi diceva, e si addormentava sempre in posti improbabili, svegliandosi con i segni sulla faccia. Giulio stava parlando della prof di matematica. «Che figa però la Marelli» ripeteva, quasi questo potesse rendere anche l’algebra più attraente; lui se la cavava con i numeri e in autunno sarebbe andato a studiare Ingegneria a Milano. A me invece piaceva dipingere, sarei andato al Dams. La Fede non lo sapeva cosa fare, ma suo padre l’aveva convinta a iscriversi a Giurisprudenza. «Diventerai una fighettina con la borsetta di Armani, penserai solo ai trucchi, ai soldi e ti rifarai le tette» le dicevo. Lei si incazzava. Stavamo insieme da due anni, due secoli nella misura temporale degli adolescenti, e non mi ricordavo più com’era cominciata. A volte mi sentivo in colpa perché non volevo scopare e lei si faceva mille paranoie. Ma non è che non la trovassi bella, è solo che, boh, non mi andava e basta.
Stavamo seduti fuori dal bar, parlavamo sempre delle stesse cose e guardavamo sempre la stessa gente scendere dagli autobus. Finché fu Andrea a scendere. Non capitava spesso che in paese arrivasse qualcuno di nuovo; non capitava mai che arrivasse qualcuno come Andrea. Noi eravamo ragazzini di periferia che facevano le marachelle e arruffavano le piume, ma il tizio che era appena sceso dall’autobus no, lui era diverso. Al posto di un ragazzo io vedevo un gatto nero, un nero gatto di città abituato a graffiare e a scappare invisibile tra i vicoli di notte, solo due occhi gialli che vibrano sui tetti. La t-shirt dei Mudhoney l’aveva certamente comprata a un concerto, non come me, che ordinavo le mie magliette dei gruppi su eBay. Dalla manica destra spuntava un pezzo di tatuaggio, il tentacolo di un polpo che, avrei scoperto qualche tempo dopo, gli occupava buona parte della schiena.
Perché un polpo?
Perché ha due cuori di riserva, se uno gli si spezza.
Andrea scese dall’autobus, si lisciò i jeans aderenti sulle gambe, fece due passi su se stesso come a scrollarsi il viaggio di dosso, si accese una sigaretta e girò la testa verso di noi. Io sentii qualcosa nelle mie budella rovesciarsi. Senza pensarci mi alzai e gli andai incontro, gli dissi una cosa idiota come: «Hey, da quando gli alieni prendono gli autobus invece delle astronavi?». MDMA mi era venuta su e mi sentivo chiaro, splendente e pieno di un amore chimico senza confini da distribuire nell’universo. Sapevo che per le successive ore avrei parlato senza sosta e avevo deciso: lui sarebbe stato il mio pubblico. Senza aspettare che mi rispondesse lo trascinai ridendo al bancone del bar. Anche lui rideva, e la sua risata aveva il suono di tante monetine che cadono per terra e rotolano via.
Dopo quella sera io e Andrea iniziammo a vederci spesso. Lui aveva preso in affitto un appartamento in cima al paese e lavorava part time al Lumo, l’unico negozio di vestiti in città che non sembrasse uscito da un catalogo per casalinghe anni Ottanta, ma non parlava mai del perché si fosse trasferito. Sapevo solo che prima aveva vissuto a Bologna, poi un poco a Torino, ma per qualche motivo non aveva funzionato. Qualunque cosa fosse, i segni sui suoi polsi mi dicevano abbastanza, quindi io non chiedevo. Forse, se l’avessi fatto, le cose sarebbero andate diversamente per lui. Ancora oggi il rimorso talvolta arriva, inaspettato e rabbioso come i temporali di quell’estate. Mi paralizza mentre lavo i piatti, così l’acqua diventa bollente e mi scotta le mani, o mentre cammino e mi ritrovo in una strada troppo in là, o mentre parlo con qualcuno e in un suo gesto o in una lieve inflessione della voce rivedo Andrea.
Di solito andavo a prenderlo al negozio poco prima che finisse il turno. Mi facevo un giro tra i vestiti mentre lui contava i soldi in cassa, ogni tanto mi provavo qualcosa e lo chiamavo in camerino per chiedergli un parere. Così iniziò il gioco, il ballo in cui io stuzzicavo sia lui che me stesso. Avevo visto come mi fissava, neanche troppo di nascosto, ma io non riuscivo a capire se questo risvegliasse in me qualcosa, oltre all’adulazione.
Ci baciammo la prima volta da ubriachi. Eravamo al pub, e aspettavamo per andare in bagno a farci una riga, io gli guardavo i capelli biondi che cadevano disordinati, l’orecchino col pendente a forma di croce e a un certo punto sentii in me una diga che crollava, lo spinsi contro il muro quasi con violenza e gli ficcai la lingua in bocca. Dalla radio del locale Brody urlava «Idoless!» e io mi sentivo proprio così: libero da ogni idolo. Lui mi lasciò fare, mi seguì nei movimenti senza andare oltre, senza chiedere di più, quasi avesse il timore di essere di troppo. Spostai la mia gamba sfiorando il suo inguine e lui si lasciò sfuggire un gemito lieve; allora capii quanto, per tutto il tempo passato assieme, lui avesse disperato per quel momento. Alla fine tenemmo per qualche secondo le facce appoggiate, le bocche vicine e lui mi guardò con timidezza, in un modo languido che, per qualche ragione, mi fece quasi arrabbiare. Fu quella la prima volta in cui riconobbi qualcosa di mansueto in Andrea, un’arrendevolezza fiacca che mi irritava, la sua parte succube alla mercé del prossimo aguzzino. Prima di staccarmi completamente, mi venne da mordergli il labbro. Si pulì con la manica un rivoletto di saliva e sangue, poi entrò in bagno.
La Fede mi mollò a metà luglio. Si era sparsa la voce che ero frocio e lei fece uno più uno con il fatto che non scopavamo da mesi. Fu meglio così per lei, le diede una scusa per ritrarsi, inacidirsi con me e tagliare i ponti. Da quel che so diventò un buon avvocato a Milano e sono sicuro si comprò una collezione intera di borse Armani da sfoggiare sui Navigli. Sviluppò un odio feroce per Andrea, però, quell’estate. Diceva in giro che era uno stronzo narcisista, che mi aveva manipolato, lo chiamava “quella puttana”. Una volta mi prese da parte e mi disse che lo era davvero, una puttana, lo aveva visto più volte uscire dalla casa del proprietario del Lumo quando la macchina della moglie non c’era. Io la compatii per quel tentativo disperato di riaffermare il proprio orgoglio, pensavo fosse solo gelosa.
Ma dove possono spingerti la gelosia, la dignità sfregiata? Quel giorno, quando trovarono Andrea con la testa nella pozzanghera, tutti scendemmo dalle case per seguire il suono delle sirene e ci radunammo per capire cosa fosse successo. La Fede era là, la vidi in mezzo alle altre teste, e questa è la verità che non ho mai detto a nessuno: non mi piacque per niente quello che lessi sul suo volto.
Il rapporto tra me e Andrea non aveva una natura precisa, o almeno non per me. Non parlammo mai sinceramente, non mettemmo mai i nostri cuori aperti e squartati sul tavolo per esaminare cosa ci fosse dentro, per poi buttarci la faccia dentro e divorarli, come a volte si fa durante le prime storie romantiche, senza badare alle cicatrici. Stavamo assieme, e io a volte volevo stargli tutto addosso, volevo possederlo, bramavo sia lui che essere come lui, un sentimento ambivalente, eccitante e odioso che non ho mai più provato da allora. Altre volte invece mi infastidiva, se mi si avvicinava sentivo come una melma unta uscirmi dai pori della pelle che mi insozzava, e davo la colpa a lui di questa sporcizia che mi rendeva disgustoso a me stesso. Se bevevo o prendevo roba, però, andava tutto bene; ci guardavamo a lungo, stavamo sdraiati per ore sul pavimento della sua stanza a parlare, ci alzavamo solo per pisciare e cambiare i dischi, uno alla volta, uno per uno, interrompendo le conversazioni durante le tracce migliori. Qualche volta prendevamo la macchina, andavamo alla discoteca più vicina, ballavamo tutta la notte e poi dormivamo nell’ultima fila del parcheggio. Mettevamo su Lou Reed prima di addormentarci abbracciati sul sedile dietro, col sole che saliva dalle montagne, mentre quella voce di satana e di padre ci diceva di stare tranquilli, era “sunday morning” e potevamo dormire, ché tanto la giornata davanti era buona solo per quello.
E quanti cuori ti rimangono?
Non ne ho più neanche uno di riserva
Per me allora non era facile comprenderlo, ma le cose così non potevano durare indisturbate, non in una cittadina che fa sì e no qualche migliaio di abitanti. Iniziarono le occhiate al negozio, niente di troppo incivile, lasciavano trasparire solo una disapprovazione velata e una certa confusione, o sorpresa – forse paura? – e qualche volta le teste si giravano troppo in fretta per non incrociare il mio sguardo.
Poi, mio padre: «Se qualcuno ti vede ancora con lui, a te ti pesto e a lui lo ammazzo». Il segno della sua mano sulla faccia mi rimase per due giorni, ma bruciò molto più a lungo. Seguirono le risate di scherno, i chiacchiericci, anche se forse quello che mi infastidiva di più erano quelli che mi adulavano, che mi dicevano che avevo coraggio. Coraggio di cosa? Io stavo solo vivendo, non volevo appartenere a nessun gruppo o categoria, non volevo essere rispettato né essere biasimato per il mio comportamento, per la mia identità abbozzata. Sperimentavo e credevo di godere del sacrosanto diritto della gioventù di non subirne le conseguenze, poco importava se in fondo lo sapevo che, alla fine, lo stronzo che paga salta fuori sempre e, se non ero io, sarebbe stato qualcun altro.
Ma c’era di più. Andrea sembrava impermeabile agli insulti, alle occhiate di sdegno o di curiosità morbosa, aveva un’accondiscendenza verso gli altri che, a un certo punto, ai mei occhi diventò arroganza. Si fece strada in me l’idea che lui si sentisse migliore di me, migliore di tutti noi che non avevamo le sue esperienze, le sofferenze incise sulla carne come uno stemma e la capacità di vedere oltre quel piccolo mondo che avevamo sempre ritenuto il nostro essenziale.
Non so quando accadde di preciso, ma un giorno mi svegliai e mi accorsi di odiarlo anch’io.
Non è tuttavia automatico fare seguire l’azione al pensiero e al sentimento, si crea spesso uno sfiato tra i due dove la riflessione si prende il suo tempo prima di diventare sostanza. Continuai quindi a vedere Andrea, anche se con indolenza. Io ero disinteressato, lui pressante. Litigavamo quasi sempre, con occasionali e brevi slanci d’affetto, rimanenze meccaniche di quel che eravamo un tempo.
Era l’inizio di settembre, quando scoprii che quello che diceva la Fede era vero. Ero a casa di Andrea e stavo cercando la coca avanzata dal sabato prima, sapevo che teneva le buste nell’armadio in camera e mi misi a rovistare fra le sue cose. Trovai la coca, ma non solo quella. Era in una scatola piena di banconote da 50 e da 100 euro, accompagnate da una lista di nomi di uomini, nomi che conoscevo bene, in prima linea quello del titolare del Lumo. Non gli chiesi spiegazioni, me ne andai mentre lui finiva di farsi la doccia.
«Ale vai già? Che torni stasera?» le ultime parole che gli sentii dire, gridate dalla finestra. Non risposi più ai suoi messaggi; quello era, in fondo, il mio biglietto d’uscita senza sensi di colpa. Se ci penso adesso, mi sembra incredibile la velocità a cui bruciammo, in fretta come la vita di una mosca, mentre allora mi pareva che Andrea e io assieme fossimo esistiti dall’inizio del mondo.
I quindici giorni seguenti i temporali furono spaventosi, restavamo tutti confinati in casa per paura di finirci dentro d’improvviso, le strade del paese erano vuote, coperte solo dal rumore senza sosta dell’acqua che si infrangeva e dalle voci su Andrea che rimbalzavano di porta in porta e che andando di bocca in bocca si facevano più grandi, allarmanti e spaventose. Andrea perse il lavoro, lo videro a far la spesa zuppo di pioggia con un occhio nero, qualcuno sul muro di casa sua scrisse “Troia!” con lo spray. Da Giulio, l’unico che ogni tanto ancora lo sentiva, a un certo punto seppi che si stava per trasferire di nuovo.
Ma non fece in tempo.
Il giorno in cui trovarono Andrea ci fu il temporale più violento di tutti. Mentre lo portavano via, tutto il paese stava in cerchio intorno all’ambulanza e alle volanti, le ultime gocce di pioggia cadevano e ci davano una scusa per tiraci i cappucci sulla fronte e nasconderci le facce. Qualcuno ebbe il coraggio di dire quello che volevamo credere: se l’è cercata.
Nessuno ebbe il coraggio di dire quello che ognuno di noi pensava davvero.
Poi d’improvviso tornò il sole e arrivarono gli ultimi giorni d’estate, tiepidi e calmi, fu come se il paese si fosse liberato di una malattia che lo affliggeva. La smemoratezza si distese sulle case come un manto di seta e gli affari ripresero, gli argomenti cambiarono, la gente risollevò i menti e tornò alla vita dove l’aveva lasciata. La Fede partì per l’università prima di me, la vidi passare in macchina con sua madre mentre stavo seduto al baretto, mi fece un cenno con la mano e un sorriso le si smorzò in faccia appena abbozzato.
Non ci lasceremo mai, vero?
Non la vidi più.
Io passai l’ultima settimana a casa assopito da una febbre leggera, il mio corpo mi aveva rinchiuso in un bozzo asettico, impedendomi di provare emozioni. Mio padre mi scrutava con un muso di ghiaccio, io lo evitavo, soffocando sul nascere i dubbi che formicavano nel mio cervello come una massa tumorale appena nata.
Non si seppe mai chi uccise Andrea, io seguii le cose da lontano, mentre la mia testa si abituava ai portici bolognesi e alle lezioni di arte e di teatro, e per un po’ ne fu distratta, tanto che pensai di essere riuscito a liberarmi della colpa senza gli strascichi del peccato. Ovviamente, non fu così.
Non si seppe mai chi lo uccise, ma dubito si fecero molti sforzi per arrivare a una conclusione. In fondo, non fu mai chi la domanda più importante di tutte.
La risposta a quella ce l’avevamo già.
Margherita Seppi